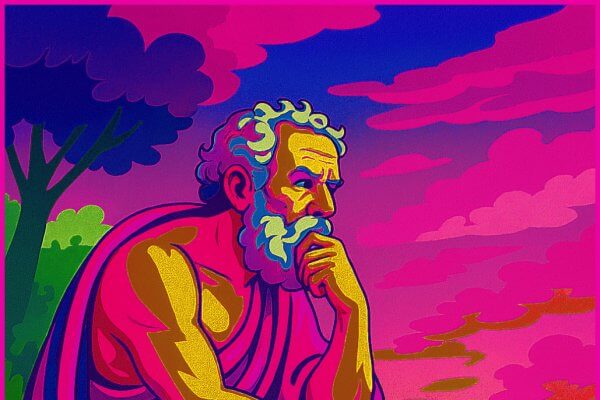SIMONDON E LA PSICOLOGIA: NUOVI ORIZZONTI DI RICERCA

Estratto di F. Sunseri, A. Le Moli (a cura di), Ambiente e tecnica. Gilbert Simondon a cent’anni dalla nascita, Mimesis, Milano-Udine 2025, p. 137; pp. 143-145.
Il centenario dalla nascita di Gilbert Simondon è stato un momento fondamentale per ripercorrere la ricezione del suo pensiero in Italia e comprendere quali possono essere le future strade da battere. La filosofia di Simondon ha certamente avuto una ricezione italiana lenta come, in realtà, è avvenuto anche in Francia. Ritengo che questo sia dovuto non soltanto alla difficile storia delle edizioni delle sue tesi di dottorato, considerate le sue opere principali, ma anche dalla difficile collocazione delle tesi simondoniane all’interno di un panorama filosofico estremamente frammentato e specializzato. Da uno studio approfondito della sua biografia si evince che lo stesso Simondon ha avuto grandi difficoltà per la sua reticenza a essere ingabbiato in ruoli e definizioni nonché per una certa ritrosia all’esposizione pubblica in tutti gli ambienti (tra cui soprattutto quello accademico) che ha fatto passare “in sordina” la sua filosofia “enciclopedica”. Simondon è stato definito filosofo della tecnica, teorico di un’ontologia genetica, ma troppo spesso si è dimenticato che era un professore di psicologia generale. E quest’ultimo non è un mero dato biografico, ma un fattore determinante per comprendere profondamente la tessitura che lega i diversi temi toccati dal suo lavoro. Prima di proporre questa lettura del pensiero simondoniano che a mio parere permette di aprire a nuove prospettive e collegamenti, è necessario riattraversare le diverse letture fatte dagli studiosi italiani per poi provare a mostrare come, a partire da esse, distaccandosi o trovandovi agganci interessanti, si possa inaugurare una nuova stagione di studi italiani su Gilbert Simondon.
[…]
Simondon non era un pensatore antropocentrico, ma riconosceva all’umano una capacità che lo rendeva differente dagli altri esseri viventi e non viventi: la possibilità e la necessità di stare in prospettiva. L’apertura topologica e cronologica del milieu dell’individuo umano determina una libertà e una condanna dell’uomo: il dover guardare oltre nel senso di pensare sempre in prospettiva di qualcosa che ancora non c’è stato. L’uomo, dunque, non può non volgere lo sguardo al futuro e questo lo rende sia capace di invenzione sia costretto a stratificare sempre più la propria psiche per tenere insieme le sfasature temporali. Ecco perché mettere il pensiero di Simondon in prospettiva non tradisce il suo dettato. Questo comporta (e comporterà) una stratificazione delle relazioni, una reticolazione che scava nel suo passato per aprire strade future. Come si affermava in apertura è arrivato il momento di inaugurare una nuova stagione di studi simondoniani che dirigano lo sguardo proprio sulla forza teorica innovativa rintracciata da Carrozzini nel 2010 nei corsi di psicologia generale tenuti da Simondon tra gli anni Sessanta e Settanta.
La questione non è aggiungere definizioni nuove a un uomo che non voleva essere definito, individuato e inquadrato, ma allargare la prospettiva. È come se fino a questo momento l’occhio degli studiosi simondoniani fosse stato estremamente miope nei confronti dell’ingombro psicologico presente nei suoi lavori. Anche da parte della famiglia Simondon sembra esserci ancora riluttanza nel dar spazio a un interesse molto ben rappresentato sia nella sua biografia (inizia a studiare psicologia fin dagli anni Quaranta e insegnerà psicologia generale fino alla fine) sia nei suoi lavori. Escluso il volume Sur la psychologie, non ancora tradotto in italiano, sembra che si voglia far passare il messaggio che gli stessi «hazard universitaire» che Simondon cita per giustificare il suo interesse per la tecnica, siano entrati in gioco anche per la psicologia. E, invece, a partire dai suoi intensi scambi con gli studiosi di psicologia più illustri dell’epoca e dai suoi interessi per la psicologia rimarcati non soltanto nelle opere più conosciute (ILFI [L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione] e MEOT [I modi d’esistenza dell’oggetto tecnico]), ma anche nel corso tenuto durante la stesura delle due tesi e nei saggi pubblicati postumi sulla cibernetica, risulta chiaro come per Simondon la psicologia abbia avuto un ruolo centrale.
Già in ILFI e in MEOT Simondon considera la tecnica come un paradigma che funziona analogicamente non soltanto alla realtà fisica e vivente, ma anche alla stratificazione della psiche. In ILFI, inoltre, si evidenzia quanto proprio l’osservazione e lo studio della complessa modalità di individuazione (individualizzazione) della psiche sia la strada per comprendere il funzionamento dei diversi processi di individuazione. In MEOT Simondon sottolinea quanto l’ostracizzazione dell’oggetto tecnico dalla cultura dipenda da un sentire archetipico: la paura dell’ignoto, di ciò che non si riesce a controllare. Il legame tra tecnica e psicologia si gioca, dunque, sull’istanza del controllo, diretta conseguenza della paura. Sia nei confronti del mondo tecnico che del mondo psichico si innesca la necessità di controllare ciò che non risulta chiaro e comprensibile.
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2025
AMBIENTE E TECNICA