IL MISTERO E IL FIORE

Nella vetrinetta di una libreria di Verona anni fa lessi:
Ci sono persone che vogliono una storia come quella di Romeo e Giulietta senza sapere che è durata tre giorni e ci sono stati sei morti: bisogna leggere! Quando entrate, ricordatevi del gradino.
Di dominio pubico, il romanzo filosofico da cui estraiamo una parte del secondo capitolo, è frutto di accurate ricerche antropologiche.
Avvio della distribuzione fissato ai primi di maggio 2023.
C’è una città di fantasia in cui convivono tutte le tradizioni matriarcali. Nei quartieri periferici si onorano le tradizioni ormai estinte; in quelli centrali gli usi e i costumi tutt’ora esistenti nel mondo. È la mitica Babilonia narratami durante l’infanzia da mio fratello Hypersio. Dopo la sua scomparsa ho scoperto che non raccontava utopie irrealizzabili: le ginecocrazie – le società dove la prospettiva femminile è al potere – esistono, o meglio, resistono ancora oggi, nonostante le persecuzioni, le influenze e le pressioni del maschilismo trionfante nel mondo.
Ad esempio, nell’immaginario quartiere Babilniyash mio fratello collocava circa 50.000 Babilini, una tribù che ha molti tratti in comune con i Mosuo residenti al confine tra le province dello Yunnan e dello Sichuan in Cina. Per intenderci ogni famiglia – Babilina o Mosuo – è mediamente composta da una ventina di persone il cui perno centrale è una matriarca eletta tra le donne più meritevoli e abili nell’organizzare le attività lavorative, nel gestire le finanze e soprattutto nel mantenimento dell’uguaglianza sociale. Le matriarche non hanno privilegi speciali ma, anzi, rappresentano tutte un esempio nella condivisione dei beni e degli spazi, a partire da quelli domestici. Sia nelle mitiche case Babiline narrate da mio fratello, sia in quelle concrete dei Mosuo, vi è un focolare mantenuto sempre acceso. È nel cuore della stanza più grande. Riscalda e illumina gli inquilini e i loro visitatori di giorno e, di notte, la matriarca e i bambini, i quali, dopo la favola della buonanotte, si addormentano nei lettini disposti intorno al suo letto. Raggiunta l’età della maturità i giovani si trasferiscono nelle altre stanze accessibili a tutti i congiunti allo stesso modo con due sole eccezioni:
LA STANZA DEI MISTERI E LE CAMERE DEI FIORI
Sia nella Babilonia di mio fratello, sia nella realtà storica dei Mosuo, la stanza dei misteri ha un accesso limitato perché è una sala parto domestica e al contempo un luogo sacro preposto alla venerazione dei defunti. La camera dei fiori invece è una stanza privata provvista di un accesso sul cortile interno e di una seconda porta che la collega direttamente alla strada. La loro chiave è il simbolo dell’autonomia e della libertà femminile in tutti gli ambiti a partire da quello sessuale: al raggiungimento della maturità – che nella mitica Babilonia è di 21 anni – ogni donna ne riceve una in dono e nessuno, neppure la matriarca, può impedirle di ospitare, tra le sue mura, gli amanti che ella desidera. Le regole da rispettare sono che, allo spuntare dell’alba, tutti gli ospiti delle camere dei fiori, devono andar via e fare ritorno alle proprie case materne; e se hanno messo incinta le donne che li hanno invitati, i figli dipenderanno solo da queste ultime e da chi vive nelle loro case. I punti di riferimento maschili sono in genere gli zii materni. Ciò non toglie che nel caso in cui i padri biologici volessero coltivare dei rapporti affettivi coi figli ne otterrebbero facilmente il permesso. Ma sinceramente questo punto lo avevo – almeno in parte – frainteso a causa della cultura androcratica della quale anche io ero parzialmente imbevuto.
Solo dopo aver stretto amicizia con due uomini Mosuo ho finalmente compreso il rapporto che nei matriarcati più radicali si instaura tra i figli e i loro padri biologici. Per non dilungarmi troppo lo sintetizzo riportando il dialogo intercorso nella prima metà del ‘600 tra un esponente dell’androcrazia occidentale, un gesuita francese, e un nativo nord americano esponente della società matriarcale dei Montagnais. Dopo aver detto al nativo che «non era onorevole per una donna amare altri che non il proprio marito» e avere aggiunto che la promiscuità sessuale era «un male in mezzo a loro» anche perché comportava per il nativo del matriarcato l’incertezza della paternità (visto che «non era sicuro che il figlio, che era lì presente, fosse suo figlio»), il missionario si sentì rispondere in questo modo:
«Lei non capisce. Voi francesi amate solo i vostri figli; ma noi amiamo tutti i figli della nostra tribù» Paul Le Jeune
Tuttavia, ai tempi in cui ero un adolescente, non capivo né l’importanza dei matriarcati, né il fatto che, quanto più una società tende alla ginecocrazia, tanto più si propaga ed afferma in essa la prospettiva materna, quella che orienta ogni membro al rispetto per la sacralità della vita e all’amorevole cura di chi ne ha bisogno, a partire dai più indifesi. Anzi, in gioventù, tutto ciò era per me solo una favoletta di mio fratello. Poi – nove anni dopo la sua scomparsa – la nostalgia mi colpì come un fulmine a ciel sereno. Avevo ventitré anni ormai e a partire da allora non ho fatto altro che domandarmi: «fino a che punto la sua Babilonia è scissa dalla realtà?». Ho inseguito la risposta nei libri e nelle conferenze di mezzo mondo. Ma l’ho anche cercata nella viva voce degli stessi ginecocratici e il primo dei tanti che ho avuto l’onore di incontrare si chiama Hanfei.
Sia la madre, sia le altre matriarche, avevano riconosciuto in Hanfei le doti per fare il sindaco, cosa che in effetti lui è ora. Ma, prima ancora di assegnargli quel ruolo politico – il più importante tra i Mosuo – gli parlarono della necessità di mettere a fuoco i rischi connessi all’improvvisa apertura al turismo. Per affrontare il problema della massa crescente di forestieri androcratici, persuasero Hanfei a studiarne la mentalità e i costumi e, con una colletta, finanziarono tutte insieme i suoi studi all’estero. Durante una cena, con la numerosa famiglia riunita intorno al fuoco, sua madre – all’epoca cinquantenne – gli posò la mano sulla spalla e gli disse: «Per capire con chi abbiamo a che fare, che ne pensi di trasferirti in Arabia Saudita per cinque anni?». «Anche io mamma!», esclamò la sorella ventenne di Hanfei e, trattendendo a stento le risa, la pregò di organizzare una colletta anche per lei. Per un momento Hanfei la immaginò in quel paese wahabita dove la libertà della donna è considerata ancora un peccato; dove le è fatto divieto di prendere la patente[1]; dove l’abito nero che la copre dalla testa ai piedi – l’abaya – può toglierlo solo tra le quattro mura domestiche; dove non può viaggiare, lavorare, accedere all’istruzione superiore, né sposare qualcuno senza il consenso di un tutore di sesso maschile. Un paese dove una donna – ma anche un uomo – che trasgredisce le regole va incontro alla fustigazione, al taglio della mano, alla lapidazione, all’impiccagione o alla decapitazione.
Ma la madre e la sorella di Hanfei gli avevano giocato uno scherzo: le androcrazie che le matriarche avevano in mente per lui non erano così radicali. La quasi totalità dei turisti è cinese, ma non mancano neppure gli occidentali, sicché infine, per conoscerli meglio, Hanfei si trasferì per cinque anni ad Hong Kong dove frequentò l’università. Fu proprio lì che io lo incontrai. Più di 9000 chilometri di viaggio per assistere alla mia prima conferenza internazionale sui matriarcati e confrontarli alla Babilonia di mio fratello.
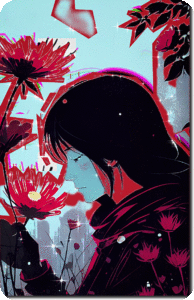
Parlai con Hanfei nella veranda di uno dei ristoranti più pittoreschi di Hong Kong. Dal nostro tavolo, accanto alla balaustra, ammiravamo l’intera baia di Causeway. Era come se le lanterne delle imbarcazioni gareggiassero con lo sfavillio delle luci dei grattacieli sull’altra sponda. Dopo averle ammirate lungamente in silenzio parlammo di donne, in particolare di quelle formatesi nelle società androcratiche. Poi chiesi ad Hanfei i motivi che lo avevano portato così lontano dalla sua terra. «Prima che arrivassero da noi i turisti», disse, «non c’era una casa Mosuo al cui interno non fosse riunita, ogni sera, l’intera famiglia in armonia intorno al fuoco. Ai pochi visitatori che giungevano dalle nostre parti davamo cibo e alloggio e ci offendevamo se ci offrivano i soldi in cambio. La mentalità individualista era fuori dai nostri confini. Oggi, all’opposto, contagia sempre più i nostri villaggi, o meglio, solo quelli che si sono aperti al turismo… Lì un numero crescente di Mosuo si allontana dai nostri costumi incentrati sulla condivisione e finisce con l’attaccarsi sempre di più al denaro, ai beni di proprietà da accumulare ad uso esclusivo…», si passò una mano tra i folti capelli corvini e con aria sconsolata aggiunse che alcuni Mosuo stavano anche subendo la fascinazione del matrimonio cinese e abbandonavano la famiglia d’origine per formarne una propria. Non capivo dov’era il problema.
Il confucianesimo aveva imposto per secoli in Cina, attraverso il Libro dei Riti, il matrimonio monogamico e la sottomissione delle mogli ai mariti, ma nel 1997 – al tempo della nostra cena – tirava un’aria diversa: come era avvenuto a partire dagli anni settanta da noi in Occidente, anche in Cina, a partire dagli anni ottanta, si era ridotto sempre di più lo stigma che da millenni aveva proibito a una donna di prendere le stesse decisioni di un uomo. Solo nelle zone rurali avresti potuto ancora trovare famiglie androcratiche come quelle saudite con l’uomo sistematicamente al comando. Quindi chiesi ad Hanfei quale fosse l’origine del suo turbamento e, dopo avermi risposto che ce n’era più di uno, mi invitò a pensare agli anziani, ai bambini e a chiunque fosse minato nel fisico. «Prendersi cura di loro», spiegò, «è di gran lunga più semplice nelle famiglie fedeli alla tradizione Mosuo rispetto alle vostre fondate sull’isolamento atomico del nucleo marito-moglie».
«Perché?» chiesi io, «Per il fatto che in una famiglia tradizionale Mosuo gli adulti sono molti di più e anche più abituati all’accudimento di chi ne ha bisogno?» Lui annuì nuovamente. «Ma c’è dell’altro!», esclamò. «Gli sposi necessitano di una casa propria. Le chance di litigare spaziano dai vari modi di gestire il denaro a quelli legati alla convivenza. Per non parlare dell’astio che esplode spesso tra chi si separa e vorrebbe avere per sé i figli, la casa, la macchina, il cane e così via. Per tutte queste ragioni si passa dall’amore all’odio e tutto ciò non avviene presso di noi fedeli alla tradizione Mosuo…».

Fece una pausa, poi disse: «Viviamo l’amore per quello che è. Non lo leghiamo né al possesso dei beni, né ancor meno all’aspettativa di possederci reciprocamente finché morte non ci separi». In effetti la pensavano così anche i Babilonesi di mio fratello e gli domandai se, come loro, anche i Mosuo non pretendessero mai l’esclusività sessuale e affettiva dal partner. «Non la pretendiamo mai!», dichiarò con fierezza, «neppure nei casi di innamoramento reciproco e tuttavia ciò non toglie che alcuni amori si protraggano spontaneamente in maniera monogamica per tutta la vita. Nella maggior parte dei casi, però, tendiamo alla monogamia solo fino a che siamo innamorati».
«E che succede quando la passione finisce?»
«Restiamo amici». Riempì di birra entrambi i nostri bicchieri, poi aggiunse: «Non capita di frequente, ma anche da noi può succedere che la persona amata perda la testa per un’altra persona e…». Fece una pausa e quello che disse poi – al pari di analoghe affermazioni di mio fratello sui Babilini – mi sembrò all’improvviso inverosimile, proprio come una favoletta. Disse: «se il cuore della persona che amiamo si volge altrove non lo riteniamo un oltraggio da punire e impedire, ma un fenomeno che può succedere a tutti, anche a noi. Per questo l’amore noi non lo trasformiamo nell’odio: perché l’odio è sempre deleterio e ridicolo; non ci renderà più desiderabili, né spegnerà la passione per la terza persona. Al contrario! La infiammerà ancora di più. La renderà più preziosa». Hanfei elaborò l’argomento da vari punti di vista, ma più ne parlava e meno attendibile mi sembrava. Poi disse: «Chiunque di noi abbia una mentalità matriarcale esalta e rispetta il femminino in ogni suo aspetto. Di conseguenza l’autonomia e la libertà sessuale delle donne viene difesa da tutti noi con fierezza. Non rappresenta per noi né un pericolo, né uno scandalo come lo è invece per gli androcratici che si impegnano molto a ingabbiarla[2]. Ecco perché quando scoprono che persino nel nostro vocabolario non ci sono parole come “matrimonio”, “moglie” e “marito”, ci trovano scandalosi e…». Si fermò.
Fece un respiro profondo. Poi mi chiese: «ma lo sai che in passato varie dinastie imperiali hanno imposto la monogamia con la forza ai nostri antenati?». Feci di no con la testa e lo invitai a parlarmene più in dettaglio. «La stragrande maggioranza ha ceduto e i loro discendenti vivono a pochi chilometri di distanza dal lago, tutt’intorno alle nostre montagne…». Sospirò e aggiunse: «…noialtri invece siamo stati salvati dalle strade impervie… le poche volte che i funzionari militari si sono inerpicati da noi a controllare fingevamo di essere monogamici ed è per questo che siamo scampati indenni alle loro persecuzioni». Si guardò intorno per accertarsi che non lo ascoltasse nessuno e, a voce bassa, mi disse: «È lo stesso stratagemma a cui è dovuta ricorrere anche la generazione di mia madre. I funzionari militari di Mao avevano l’ordine di ridurre alla fame qualunque Mosuo che rifiutasse di sposarsi e, quel che è peggio, persino i bambini nati fuori dal matrimonio dovevano morire di fame. Per di più incitavano i neo-mariti a gestire i soldi e ad assumere il comando sulle proprie mogli… Di conseguenza nei mesi in cui salivano a controllarci i nostri genitori hanno dovuto fingere… pur di salvarsi… salvarci… anche mia madre fingeva…».
La donna è sottoposta al potere dell’uomo (potestà maritale) oltre che al potere politico, a quello di clan e all’autorità religiosa. Questi quattro poteri rispecchiano l’insieme dell’ideologia e del sistema feudale-patriarcale e sono i quattro grossi vincoli che tengono avvinto il popolo cinese, e in particolare i contadini.
Mao, Libretto rosso
Nelle culture matriarcali viene dato grande valore alla sessualità; si pensa che una vita sessuale soddisfacente sia fonte di salute, pace e cultura.
Heide Goettner-Abendroth, LE SOCIETÀ MATRIARCALI, studi sulle culture indigene del mondo, Edizioni Venexia, Roma 2013, p. 652
[1] Solo nel 2018 le donne saudite hanno ottenuto il diritto di guidare, sempre però con il consenso di un uomo nominato loro tutore.
[2] Persino oggi, nei paesi dove l’androcrazia è forte, se l’uomo non tiene sotto chiave la moglie lui rischia di diventare un “cornuto”, lei una “zoccola” e i loro figli “bastardi” o “figli di puttana”. Questa onnipresente e asfissiante repressione del femminino ha nelle società androcratiche l’effetto di potenziare, promuovere e dare per assodata la mania del possesso, la supremazia del più forte sul più debole e il dominio degli uomini sulle donne ridotte a manipolabili oggetti d’uso.
@ILLUS. by MAGUDA FLAZZIDE, 2023
DI DOMINIO PUBICO








Il romanzo di dominio pubico è di godibilissima lettura è tutto dedicato alle culture delle società matriarcali. L’impero delle donne è un momento di passaggio. Dal regno del dono è della condivisione libera di risorse e piaceri si passa alla legge, al sistema di divieti e punizioni del patriarcato moderno. Un libro che indica la rotta per un presente nuovo e migliore