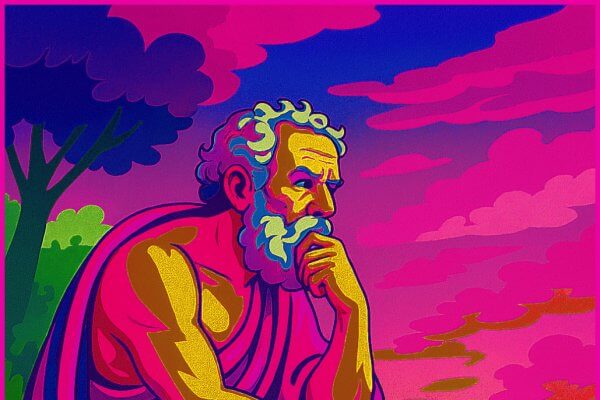ARENA PHILOSOPHIKA: EST

“Il discorso relativo alla conoscenza da parte del Creatore – sia lode a Lui! – di sé e del diverso da sé, è uno di quelli che è proibito analizzare in modo dialettico durante le dispute, men che meno scriverne un libro, poiché la comprensione delle masse non arriva a simili sottigliezze. Se si indugia a discutere col volgo di siffatte [questioni], si annulla nelle loro menti il significato [stesso] dell’essere di Dio: per cui l’approfondimento di questo tipo di conoscenza è proibito alle masse, dal momento che per la loro felicità è sufficiente sapere quanto davvero sono in grado di capire.”
Così Averroè (Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd) in una delle tante tirate d’orecchie ad al-Ghazali (Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-tusi, Algazel). Il primo (nato nel 1126 d.c.) se la prende col secondo (morto nel 1111 d.c.), reo di aver scritto un libro (L’incoerenza dei filosofi) cui non si poteva che controbattere (con L’incoerenza dell’incoerenza dei filosofi).
Ciò ci introduce al nostro blog Arena Philosophika: in un tempo in cui il comando del demos è realtà (ma davvero?) non vi sono più gradi da rispettare e ogni cittadino (idiotes) ha il diritto/dovere di pensare (ovviamente). Come dice Paolo Flores d’Arcais “laddove c’è libertà di opinione, ciascuno non solo si fa il proprio Dio (unico) a immagine e somiglianza, ma ha il diritto di farselo”.
La democrazia e l’ethos (comportamento) della comunicazione dei tempi correnti (che è la magnificazione della capacità di comunicare, non trasmissione di contenuti) permettono qualunque teomachia. Tali epici scontri non possono che andare in scena in un’arena, per esempio in Arena Philosophika. Conflitti (Divini) che non possono che abitare i discorsi perché solo in questi appaiono. Spettacolari combattimenti discorsivi (logici). (Se si passa ad altri tipi di lotte ogni dubbio sulla contraddittorietà o meno delle asserzioni di un questionante o dell’altro viene fugato in una evidente e non negabile rissa o battaglia).
Tralasciando, dunque, le cose di poco conto, ossia le cose, componenti (meroi) poco interessanti del Tutto, ci si getti prestamente sul bersaglio grosso (per esempio), ciò che è valido o che è ritenuto tale (Axios), che taluni chiamano Dio, senza paura di incorrere nelle persecuzioni di qualcuno più meritevole di tali indagini, “poiché la libertà religiosa annichilisce la nozione stessa di eresia”.[1]
Daje! Tutti finalmente possono provare la suprema libidine di dire la propria a proposito del Tutto, della Natura, del Dio o non Dio e di scontrarsi ferocemente con chiunque dica cose sconsiderate. Fiduciosi che “[d]iscutere di queste questioni con le masse non sia[2] come iniettare nel corpo di molti animali un veleno che per loro costituisce una pozione letale” né che i crani degli internet-nauti frequentatori di Arena Philosophika esplodano non potendo contenere l’eccessiva mole di ragionamenti.
Ed ecco allora che ci si può schierare (o anche no) con al-Ghazali nel dire che un Dio che conosce solo sé stesso (affermazione obbrobriosa da cui scagiona Avicenna ma non altri filosofi “più veritieri”) renderebbe i propri effetti (il mondo) superiore a Lui. E tra l’altro “[q]uale splendore può trovarsi in un’esistenza semplice priva di quiddità e sostanzialità […]? Quale deficienza nell’intera realtà di Dio potrebbe apparire maggiore?”. Un Dio così deficiente sarebbe non molto differente da un morto se non per aver consapevolezza di sé. E anche se così fosse dovremmo dire, secondo al-Ghazali, che Dio non coincide con la conoscenza di sé stesso e dunque sacrificarne l’unità e introdurre una pluralità (Dio e la conoscenza che Dio ha di sè). Poiché anche questa minima consapevolezza di Dio ne sarebbe un attributo.
Ed è forse riconoscendo questa problematicità di fondo che l’uomo dei tempi correnti, risolvendola inconsciamente, non ha bisogno di affermare che Dio, che è Uno, non ha scienza di sé e dunque è proprio come un morto. E ammettendo che questo sia il giusto modo di dirimere la questione, rimarrebbe comunque un problema. Tutto il resto è ancora lì. Resta inspiegato.
P.S. Al-Ghazali vorrebbe screditare i filosofi e la logica, sostenendo che non possano quelli arrivare a una comprensione neppure approssimativa di Dio. Pur non essendo egli immune al fascino della razionalità, coerentemente con il suo spirito mistico, sostiene che la certezza può essere frutto solo dell’ispirazione divina, di un dono gratuito dell’Altissimo: «Colui cui Dio ha aperto il petto alla fede […] avanza alla luce del Signore»
[1] Scrive Paolo Flores d’Arcais.
[2] Averroè scrive “è”, io ho cambiato in “non sia”.
Citazioni di Averroè tratte da L’incoerenza dell’incoerenza dei filosofi, UTET, 1997 – Torino, così come di al-Ghazali di cui anche La bilancia dell’azione, UTET, 2005 – Torino (nel P.S.), entrambi a cura di Massimo Campanini. Citazioni di P. Flores d’Arcais tratte da “La democrazia ha bisogno di Dio” Falso!, Laterza, 2013 – Bari. Flores d’Arcais non sarebbe entusiasta delle teomachie qui paventate.