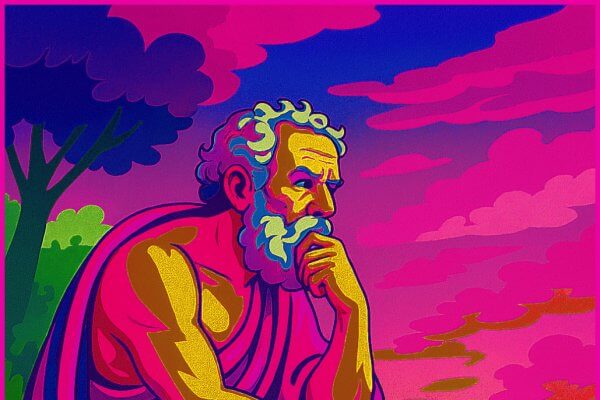L’ANTROPOLOGO DI KÖNIGSBERG: KANT FILOSOFO MONDANO

Quando si dialoga intellettualmente con un autore, specialmente con uno di quelli che ormai costituisce un consolidato patrimonio comune all’interno di una vera e propria classicità moderna, è quasi consuetudine immaginarselo secondo le direttive del suo stesso pensiero, facendo quindi dell’uomo e della sua dottrina un’unica e inscindibile istanza. Quanto più eminente è il pensiero di un filosofo, tanto più si tende (non sempre a torto, in verità) a immaginare la sua vita e la sua condotta in quegli stessi termini magniloquenti. In quest’ottica, al nome di Immanuel Kant non possono che venire associate tutte quelle caratteristiche che giustificano, in un uomo, la qualifica di pensatore, e che Herder compendiò splendidamente nel ricordo commosso del suo maestro:
Nulla che fosse degno di esser conosciuto gli era indifferente; nessuna cabala, nessuna setta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo, aveva per lui il minimo pregio di fronte all’incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé; il dispotismo era estraneo al suo spirito. Quest’uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Emanuele Kant: la sua immagine mi sta sempre dinanzi.
È pur vero, d’altro canto, che dietro ad ogni pensiero, persino il più complesso e articolato, si cela sempre un uomo in carne ed ossa che si trovò ad essere un soggetto storico: un individuo calato in un determinato periodo storico e in un contesto sociale suo proprio. Occorre dunque, nel caso di Kant come in quello di ogni altro filosofo, mettere temporaneamente tra parentesi gli aspetti più rilevati dalla storia della filosofia per far la conoscenza di un uomo che, passato alla storia come il fondatore della filosofia trascendentale, ebbe modo di essere apprezzato dai contemporanei (amici, conoscenti, studenti, concittadini, commensali) anche e soprattutto come membro attivo di una comunità, quella di Königsberg, minuta ma viva e pulsante.
Esistono, com’è noto, un buon numero di fonti da cui attingere particolari biografici della vita di Kant, da quelle che ci informano sulla puntualissima passeggiata pomeridiana fino a quelle che ironizzano sul sempiterno celibato del saggio di Königsberg. Ma vi è pure una fonte non esterna, ovvero redatta dallo stesso Kant, che ci consente di sbirciare alcuni interessanti aspetti della sua considerazione mondana della vita e dell’uomo. Si tratta di un’opera pubblicata da Kant nel 1798, quando il grande pensatore aveva già raggiunto i settantaquattro anni di età. Pensata come una silloge degli insegnamenti del semestre invernale che Kant aveva per trent’anni somministrato ai suoi studenti, l’Antropologia Pragmatica non fa parte del corpus delle opere critiche, ma anzi se ne distanzia per ragioni stilistiche, metodologiche e per il fine che si propone.
Se la domanda di fondo delle critiche kantiane viene generalmente sintetizzata con la formula “che cos’è l’uomo?”, l’interrogativo e il fine che si pone l’Antropologia Pragmatica assume invece un tono meno teoretico, più attento alla dimensione umana in senso mondano e quotidiano. Che cosa si deve fare dell’uomo? È questa la domanda, squisitamente pragmatica, che funge da architrave per l’intera opera; tanto che si potrebbe quasi descrivere il libro come una sorta di agile manuale del funzionamento dell’uomo in società e dei comportamenti da adottare per una corretta fruizione dell’umanità media.
Va però fatta, prima di inoltrarsi nella discussione circa le peculiarità dell’opera, una piccola premessa. L’idea che si ha comunemente dell’antropologia richiama immancabilmente certi elementi e metodi ormai divenuti tradizionali all’interno di questa disciplina. L’antropologia moderna, fondata da studiosi come Evans-Pritchard e Malinowski, ha connotati caratteristici che rendono la figura dell’antropologo ben delineata presso l’immaginario comune. Un antropologo, agli occhi delle persone, è colui che si dedica allo studio di una cultura differente e molte volte lontana da quelle a noi più prossime (è il caso, per continuare a utilizzare gli esempi dei due campioni poco sopra citati, degli Azande di Evans-Pritchard e dei Trobriandesi di Malinowski); elemento di un certo rilievo, dunque, sembra essere quello del viaggio di scoperta che mette l’antropologo in diretto contatto con la società oggetto del suo interesse. L’antropologia per come la si conosce al giorno d’oggi è, insomma, una disciplina inclusiva e mobilitante. Fatta questa osservazione preliminare non può che sorgere, in relazione all’antropologia kantiana, una domanda non banale: in che senso si può parlare di un’antropologia se colui che la illustra, com’è ben noto, non si mosse mai dalla piccola e isolata cittadina di Königsberg? Ben conscio di questa possibile obiezione alla sua opera, è lo stesso Kant che, nelle prime battute del libro (e a monte del riconoscimento accordato al viaggio nella pratica antropologica), chiarisce la sua posizione in merito:
Ai mezzi per l’ampliamento dell’antropologia appartiene il viaggiare, sia pur anche soltanto la lettura dei libri di viaggi. Ma si deve prima aver acquistato a casa, nelle relazioni coi propri concittadini e compaesani, la conoscenza degli uomini, se si vuol sapere dove si deve cercare all’estero il modo di estenderla.
Una considerazione che viene prontamente corredata dalla seguente nota a piè di pagina:
Una grande città, centro di uno Stato, dove si trovano i consigli locali di governo, che possiede un’università (per la cultura scientifica) ed è anche sede di commercio marittimo, che per mezzo di fiumi favorisce il traffico dall’interno e coi paesi finitimi e lontani di diverse lingue e costumi, una tal città, come è per esempio Königsberg sul Pregel, può esser presa come sede adatta per l’ampliamento della conoscenza dell’uomo e per la conoscenza del mondo, la quale vi può essere acquistata anche senza viaggiare.
Queste le ragioni addotte dal filosofo in relazione alla sua antropologia “statica”. E dunque il primo fondamentale nucleo antropologico di riferimento sarà l’insieme dei propri concittadini, che si ritrovano ad essere i protagonisti delle osservazioni “pragmatiche” di Kant. Come detto in precedenza, l’Antropologia non appartiene all’insieme delle opere critiche. Pur mantenendo un’architettura interna sistematica e rigorosa, con una suddivisione in capitoli e paragrafi che prendono ad analizzare l’uomo partendo dalla sensibilità esterna per giungere alla trattazione del senso interno, lo stile dell’opera è più lieve e meno tecnico se paragonato a quello talvolta convulso delle tre critiche. Non mancano, beninteso, elementi di comunanza, specialmente nel caso di alcuni temi che non possono non rimandare al più vasto contesto della ragion pura, di quella pratica e del giudizio (nel paragrafo sulla saggezza dell’uomo, ad esempio, ci si trova dinnanzi a una brevissima disamina sulle idee e sulla loro natura, tematica fondante della Critica della Ragion Pura la cui trattazione è contenuta in uno dei capitoli più pregni e significativi dell’intera opera). Non sarebbe dunque difficile tracciare un parallelo tra la visione antropologica e quella più schiettamente teoretica del pensatore di Königsberg, ma per evitare una ricomprensione forzosa della prima nella seconda sarà meglio identificare quello che, invece, è l’effettivo nucleo di originalità del metodo antropologico di Kant.
Si tratta, per buona sostanza, di una differenziazione sul piano stilistico; e non solo per quel che riguarda la chiarezza in sé dell’esposizione, elemento che sicuramente rende l’Antropologia più fruibile di molti altri scritti kantiani. Il punto è che l’Antropologia, a differenza delle critiche, non si limita all’enucleazione rigorosissima ma asciutta dei propri argomenti, bensì ricorre, per connotarli a dovere, di un congruo numero di esempi chiarificatori. L’uso dell’exemplum, assai spesso latitante nelle opere teoriche di Kant, è il grande protagonista della sua antropologia pragmatica. La cosa non deve stupire eccessivamente. In fondo, all’uomo ideale oggetto delle critiche viene qui contrapposto l’uomo reale, mondano, quotidiano con cui Kant doveva fare i conti tutti i giorni, e che certamente non mancò di fornire al filosofo tutta una serie di suggestioni pratiche da inserire come corollario alle sue osservazioni di antropologo.
Alcuni degli exempla di Kant assumono talvolta un retrogusto spassoso, vuoi per la loro infondatezza scientifica, vuoi per la loro intrinseca eccentricità. Varrà perciò la pena di riportarne almeno qualcuno.
Nel paragrafo dedicato alla pusillanimità e al coraggio, Kant distingue proprio quest’ultimo dalla pazienza, una virtù che, a suo dire, assume un carattere femmineo, poiché non offre forza alla resistenza, ma spera di rendere insensibile il dolore per mezzo dell’abitudine. Decisamente suggestivo l’esempio esplicativo che compendia questa definizione:
[…] è come l’imprecazione, quando nel camminare si urta (col pollice del piede, onde è venuta la parola hallucinari) in una pietra che sporge dal terreno, piuttosto un’espressione dell’ira, in cui la natura si sforza di sciogliere per mezzo del grido l’arresto del sangue nel cuore.
Ecco spiegata, secondo l’antropologia kantiana, la nostra incontenibile volgarità durante gli incontri ravvicinati con irregolarità del terreno e spigoli di comodino.
Di un certo interesse è poi lo spazio che Kant dedica al gusto e che, come si può facilmente immaginare, intrattiene qualche significativo nesso con la Critica del Giudizio. A partire dalla distinzione fra gusto riflesso e gusto riflettente (con evidente simmetria in relazione ai rispettivi giudizi):
Ma c’è anche un gusto apprezzativo, la cui regola deve essere fondata a priori, perché essa rivela una necessità, e quindi anche una validità per ognuno circa il modo come la rappresentazione di un oggetto deve esser giudicata per rapporto al sentimento di piacere e dispiacere […]. Questo gusto si potrebbe chiamare riflettente per distinguerlo da quello del gusto empirico come gusto fondato sulla sensazione (quello gustus reflectens, questo reflexus).
Eppure, accanto a quella che si presenta come una descrizione in stile squisitamente kantiano, viene accostato un exemplum quasi insospettabile. Colui che, integrando con arguzia le due modalità del gusto e dando luogo a una mediazione, riesce a universalizzare il proprio criterio operativo (acquisendo così la qualifica di uomo sapiente) è… il buon albergatore:
Il gusto estetico dell’albergatore si dimostra nella sua abilità di scegliere i cibi in modo universale; […] Egli dunque impianta il suo esercizio sulla base della molteplicità, in modo cioè che ciascuno trovi pronto qualcosa secondo il suo gusto: il che produce una relativa universalità. […] Così il sentimento organico, per mezzo di un suo senso particolare, ha potuto fornire il nome per un sentimento ideale, cioè per una scelta sensibile universalmente valida.
Il fatto che Kant riservi un posto d’onore ad osti e albergatori apparirà meno bizzarro se si tiene conto della assai vivace vita mondana del filosofo stesso, ospite e commensale graditissimo (stando alle fonti) a tutti i banchetti ai quali veniva puntualmente invitato. E proprio il banchetto costituisce uno snodo fondamentale di tutta l’Antropologia, al punto da figurare come centro nevralgico del capitolo dedicato nientemeno che al sommo bene fisico-morale:
La specie di benessere, che sembra meglio accordarsi con l’umanità, è un buon pranzo in buona (e, se possibile, anche varia) compagnia […].
A tutto ciò aggiungendo una sorta di minuziosa cabala che identifica nel numero dieci (senza contare l’eventuale padrone di casa qualora si tratti di un banchetto domestico) la quantità di individui perfetta per la buona riuscita del simposio. Un quantitativo che, per usare le parole del conte di Chesterfield citato da Kant, non deve essere al di sotto del numero delle Grazie, né al di sopra di quello delle Muse.
Ed anche a sé stesso, oltre che a tutti i suoi pari, Kant sembra prescrivere la buona pratica del banchetto in compagnia, in quanto proprio esso, oltre a rispondere alla domanda precipua dell’Antropologia sull’uso pragmatico dell’essere umano, non può che costituire un balsamo per tutti coloro che si affaticano costantemente nel difficile esercizio del pensiero:
Il mangiar da solo (solipsismus convictorii) non è salutare per un filosofo; non vi è ristoro, ma (specialmente quando la tavola diventi una gozzoviglia solitaria) esaurimento; è un lavoro che logora, non un gioco di pensieri che ravviva. Il gaudente, che durante la mensa solitaria si strugge di pensieri in sé stesso, perde a poco a poco ogni brio, che invece acquista quando un compagno di tavola gli offre con le sue varie trovate nuova materia di vita, che egli stesso non avrebbe saputo trovare.
Per vedere tutti gli articoli della serie Dietro il filosofo: l’uomo e le Idee, clicca qui.
@ILLUS. by JOHNNY PARADISE SWAGGER feat. PATRICIA MCBEAL, 2020
DIETRO IL FILOSOFO: L’UOMO E LE IDEE
@GRAPHICS by AGUABARBA, 2020