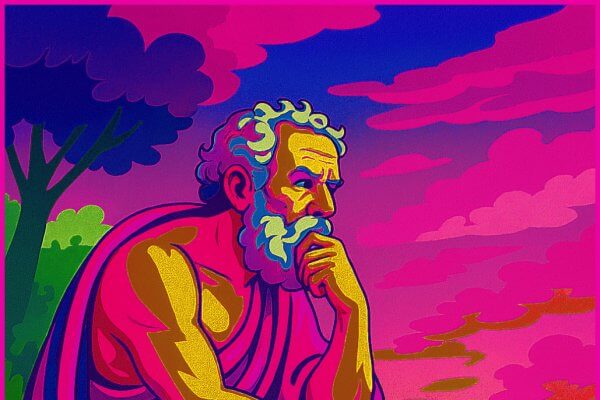MORTE DI GESÙ O MORTE DI SOCRATE? SULLA DEELLENIZZAZIONE DEL CRISTIANESIMO

Dio è morto. Già da un pezzo. I cristiani non ancora.
Se Nietzsche sentenziava la svalutazione di un dato ordine (a quel punto non immutabile) di valori e ne pronosticava un altro venturo, chi vedeva in Dio non un sistema di idee solo idealisticamente trascendentale a uso di un Intelletto immanente, bensì, piuttosto, una speranza, si riorganizzava.
Così per esempio Martin Heidegger, figura eminente del novecento sul tema. Anche per lui l’uomo ha oramai esperito la morte di Dio, tuttavia non da intendersi come “tesi metafisica” sulla Sua non esistenza, ma come indice della insostenibiltà del Dio filosofico. “[N]on c’è più nessun Dio che raccolga in sé, visibilmente e chiaramente, gli uomini e le cose” (M. Heidegger, Perchè i poeti?, La Nuova Italia, Firenze, p. 247)
Heidegger può essere considerato il principale fautore di quel processo di deellenizzazione del cristianesimo, volta a superare “la deformazione dell’esperienza fattuale cristiana a opera di un filosofia greca pessima ed epigonale” (Aniceto Molinaro).
Il suo è “un vero e proprio programma: 1) rompere il sistema teologico-metafisico del cattolicesimo, […] (pars destruens); 2) adoperarsi per una riscoperta del cristianesimo autentico, liberato dall’ontologia greca, […] attraverso una revisione della sua concettualità ormai data per scontata (pars construens)” (Leonardo Messinese).
Il “sistema del cattolicesimo” è per Heidegger “problematico e inaccettabile“, ma non lo sono “il cristianesimo e la metafisica (quest’ultima, tuttavia, in un senso nuovo)” (M. Heidegger, Lettera a Engelbert Krebs, 1919).
Per fare ciò “devono essere reimpostate tutte le domande filosofiche e dunque anche la domanda filosofica su Dio” interpretando “[l’]esperienza della vita cristiana in termini ermeneutici-fenomenologici e, cioè, senza contaminazione teoretica” (Friedrich-Wilhelm von Herrmann su Heidegger).
Heidegger si volge così all’Epistolario paolino nel tentativo di cogliere i motivi dell’esistenza cristiana ai suoi albori e, con ciò, se ne fa esegeta. Certo con metodo ermeneutico-fenomenologico piuttosto che dogmatico-teologico, ma la sua pretesa di condurre un ateismo metodologico nel volgersi a una religione storica determinata in questo modo non convince.
Ciò a introduzione del discorso che di seguito nell’articolo procede, esplorando i risultati ottenuti da un altro esegeta cristiano, Oscar Cullmann (1902-1999). Teologo francese, luterano, è sicuramente da annoverarsi tra le figure che si sono adoperate nel proposito di discernere chiaramente tra la concezione religiosa dei primi cristiani e quella caratterizzata da forti influenze della filosofia greca che costituisce l’ortodossia cattolica.
Egli, difatti, insistette sulla marcata differenza che intercorre tra le figure di Socrate e Cristo nell’affrontare l’attesa, della propria morte, certa.
“Socrate affront[a] la morte con una calma e serenità assolute”, poiché egli è convinto che “essa liber[i] dal corpo”. Seppure non matematicamente sicuro dell’immortalità dell’anima, Socrate la considera un’evenienza così probabile da essere un “rischio allettante” (per usare l’espressione che gli fa pronunciare Platone nel Fedone). “Perché la filosofia ci permette sin d’ora di penetrare nel mondo eterno delle idee al quale appartiene l’anima, e di liberarla quindi dalla prigione del corpo” (Cullmann su Socrate).
Perciò Socrate non teme la morte e accetta, di buon grado, di sorseggiare la cicuta andando incontro alla propria sorte. Ma come è morto, invece, Gesù?
Gli evangeli sinottici sono concordi tra loro in merito all’evento del Getzemani: Gesù comincia a “tremare e a essere preso dall’angoscia” (Marco, 14,34). “La mia anima è afflitta fino alla morte”. Il messia, dunque, si rivela del tutto umano nell’esperire “la paura naturale che ci ispira la morte”. Secondo Cullmann al Nazareno, divino Figlio, spetta di “provarla ancora in forma più terribile”. Perché la morte è “la grande potenza del male”.
Gesù infatti chiede al Padre che gli venga risparmiato il passaggio necessario della morte: “Tutto è possibile a te, fa che questo calice si allontani da me” (Marco, 14,36); mai si sente pronto per morire: “Di quel battesimo dovrò essere battezzato, e quanta angoscia sento, finché non sarà compiuto!” (Luca 12,50).
Gesù sa che la morte, nemica di Dio, è “isolamento estremo, solitudine radicale”. A ciò non vuole abbandonarsi, vuole restare col padre.
Per questo Cullmann scrisse : [n]on si può immaginare contrasto più grande di quello fra la morte di Socrate e la morte di Gesù”. “Gesù è passato realmente attraverso la morte in tutto il suo orrore, […] anche nell’anima“.
Il Cristo che avrebbe vissuto la morte dell’anima determina una concezione della stessa incompatibile col senso greco (socratico-platonico) dell’immortalità di cui s’impregna il cattolicesimo. Cullmann infatti sostenne che l’immortalità dell’anima è “uno dei più gravi fraintendimenti che riguardano il cristianesimo”. Poiché “per i primi cristiani l’anima non è immortale in sé, ma lo diviene unicamente grazie alla risurrezione di Cristo“. Egli è “il primogenito fra i morti“.
La speranza cristiana dunque non sarebbe quella che più comunemente s’intende, ma, d’altronde, “[l]’im-mortalità in fondo è un concetto negativo”. L’anima semplicemente non morirebbe. Invece la risurrezione “è un concetto positivo“.
Cullmann abbraccia la speranza che “l’uomo intero“, con tutto il suo corpo, venga “richiamato alla vita da un nuovo atto creatore di Dio“. “Creazione nuova della materia, d’una materia incorruttibile”. Σῶμα πνευματικός (Soma pneumatikós) per dirla con San Paolo.
La risurrezione dei fedeli cristiani può avvenire solo dopo previo passaggio dalla morte dell’anima. E tale risurrezione è attesa alla fine dei tempi, come avverte Tutto il Nuovo Testamento. “L’ultimo nemico che sarà vinto è la Morte” (Corinzi I, 15,26). In ciò Cullmann si scosta anche da Karl Barth: la trasformazione del corpo fisico non avviene al momento della morte come se i trapassati stessero fuori del tempo. San Paolo spesso dice che “essi dormono”, ma, nell’interpretazione di Cullmann, ciò significa che essi si trovano “in un tempo intermedio per i morti” in attesa di avere il loro corpo ricreato da Dio. Nell’attesa non sono soli, ma con Gesù, se credono.
Ecco spiegato perché “[l]a dottrina del grande Socrate, del grande Platone, è incompatibile con l’insegnamento del Nuovo Testamento”.
Citazione di L. Messinese tratte da Le stanze della metafisica, Morcelliana, dal primo capitolo, su Heidegger. Da questo anche la citazione della Lettera di Heidegger a Engelbert Krebs. Citazioni di A. Molinaro e F. W. von Herrmann tratte da Heidegger e San Paolo, Interpretazione fenomenologica dell’epistolario paolino. Riferimenti e citazioni di O. Cullmann reperiti in O. Cullmann, Immortalità dell’anima o risurrezione dei morti, Paideia Editrice, Brescia. Che l’immortalità, che si dica dell’anima o di qualsivoglia cosa, sia “un concetto negativo”, come asserisce Cullmann, si può affermare se la morte è innanzitutto entificata e, così, resa un positivo. Tale che negare la morte sia negare un positivo. Se, tuttavia, la morte è quel positivo-che-nega, essa è un negante-che-non-nega sé stessa. Nega, però, per l’appunto, i positivi ed è dunque la morte a essere di ardua gestione logica (discorsiva). Se la morte è innegabile, allora essa è; ma cos’è? Vd. Mistero.
Per vedere tutti gli articoli di Cristologia portami via clicca qui.
@GIF by JOHNNY PARADISE SWAGGER, 2019