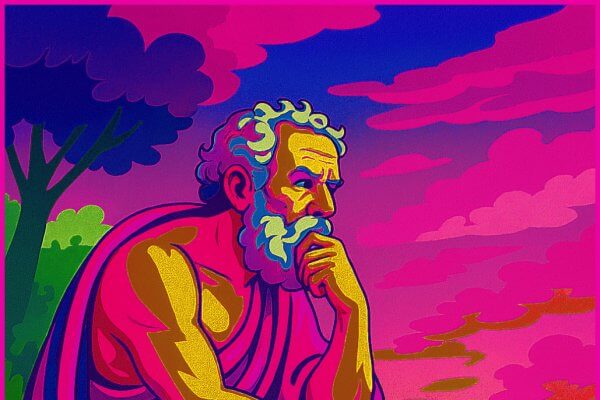DEL MESSIANISMO TRA TEOLOGIA E FILOSOFIA

Chi è il Messia? È il consacrato del Signore, l’unto dal Signore, letteralmente il Salvatore. Non si limita solamente ad essere una guida spirituale per l’intero popolo, ma ne rappresenta anche un leader politico; la consacrazione di Davide ne è chiara prefigurazione. In quanto leader politico, è naturale che il popolo ebreo abbia visto in lui una figura carismatica e salvifica, da contrapporre al potere romano. Il Messia è, pertanto, l’incarnazione del nuovo Davide, del nuovo re di Israele liberatore e salvatore. Se pensiamo alla figura di Gesù, non possono che sorgere alcune domande: fu egli il Messia? E, soprattutto, Gesù si è mai presentato e considerato come Messia, Figlio di Dio e Dio stesso? In poche parole, Gesù si è considerato il Cristo di Dio? In questo articolo non risponderò direttamente a tali quesiti, ma saranno centrali per comprendere la posta in gioco del messianismo tra teologia e filosofia
Il messianismo, come si può facilmente comprendere, è un problema, una questione tutt’ora spinosa, che ha trovato nella filosofia terreno fertile per il suo sviluppo. In quanto concetto bifronte, teologico e politico insieme, è stato oggetto di differenti reinterpretazioni. Qui evidenzierò brevemente la posizione di Küng, ponendola in confronto con quella di Jaspers.
Per il teologo tedesco, il messianico acquisisce un senso del tutto peculiare: messianismo come instaurazione del Regno di Dio; questo sarebbe il centro dell’insegnamento di Gesù di Nazareth. Ma cosa è questo misterioso Dei Regnum? Innanzitutto, è il Regno eterno di Dio, non solamente quello storico iniziato con la creazione, ma quello escatologico, che viene nel tempo finale e che pone termine alla storia; non è un governo teocratico, un assegnare potere ai sacerdoti, magari rivolgendo il potere costituito con mano armata, quanto più una pacifica attesa fiduciosa nel diretto dominio di Dio; non è la celebrazione dei giusti e dei pii e giudizio implacabile e senza possibilità di appello per i negletti, bensì grazia incondizionata e annuncio della lieta novella (Vangelo) proprio ai derelitti diseredati, né, infine, regno antropomorfo, plasmato dalla casta degli eletti, perché regno «la cui creazione dipende dalla libera iniziativa di Dio»[1]. Come si può notare, il messianico si presenta comunque come iniziativa libera di Dio che redime il mondo dalla sua mondanità pesante.
Pur nella comunanza di questa attesa speranzosa e fiduciosa nell’intervento purificatore di Dio, la posizione cristiana e quella ebraica divergono su di un punto dirimente: l’ebreo aspetta e spera nell’avvento del Messia, mentre il cristiano nel suo ritorno. Per quest’ultimo il Messia è già venuto, ha già portato termine alla storia; il Messia che nel futuro ritornerà non sarà il Messia del futuro, ma quello escatologico; anzi, con la venuta del Messia si è già instaurata l’epoca escatologica, del tempo ultimo, al cui termine non ci sarà il nulla, ma Dio. Ecco perché era credenza dello stesso Gesù, il Messia, che in un brevissimo lasso di tempo sarebbe giunta la fine di tutto e la discesa dal cielo della Gerusalemme celeste. Comprensibile, allora, del perché questa «attesa a breve scadenza», come la definisce il teologo cattolico, si collochi nella polarità tra il “non ancora” e il “già”. Ma ciò che qui è interessante notare è che tale divaricazione temporale lascia aperto uno spazio; tra il “non ancora” (perché futuro) e il “già” (perché passato) c’è il presente, che è un dono. Ed è solo in esso che è possibile edificare; in quanto ‘tra’, in quanto Zwischensein, l’uomo deve prendere decisioni, deve rischiare, assumersi le proprie responsabilità. Ma l’occhio e il cuore devono essere sempre rivolti al futuro, a quel “non ancora” di cui il “già” non è altro che preparazione, nel qui del dono: «[l]a prospettiva del futuro di Dio deve modellare il nostro presente individuale e sociale. Già qui e oggi»[2].
Come che sia, l’uomo non può rendere presente il Regno di Dio; lo può invocare, chiamare a gran voce, può appellarvisi nella profondità della segretezza della preghiera personale, ma mai può realizzarlo. Qual è, allora, lo spazio per l’azione dell’uomo nella decisione? La decisione è nell’affidarsi, con fede, con fede fidente (vertrauende Glaube) alla realtà di Dio, riconoscendosi in una situazione critica, perché estremamente caduca. È solo a partire dalla speranza per il futuro, nel presente, che si può ottenere quella forza per cambiare il presente; allora, il compimento autentico sopraggiunge esclusivamente «tramite l’azione di Dio, un’azione che non si può né prevedere né estrapolare. Un’azione, s’intende, che non esclude, ma include l’azione dell’uomo qui e ora, nell’ambito individuale e sociale»[3]. In poche parole, il Regno di Dio è dono di immenso amore, è Grazia di Dio.
Come si inserisce in questa discussione Jaspers? A dire il vero, a quanto ne so, non mi è parso che la problematica messianica susciti così grande interesse nel filosofo tedesco; non ha ma dedicato uno studio di ampio respiro a tale tematica infatti. Ma un indizio indiretto può fornire da spunto per future riflessioni; è un passo contenuto nel Die Großen Philosophen (I grandi filosofi), precisamente nel profilo dedicato a Spinoza.
Spinoza non ha soltanto respinto la reale attesa del Messia e quella conseguente del ritorno di Cristo come rappresentazione religiosa inaccettabile da parte della ragione filosofica, ma anche la cifra del pensiero messianico. Non conosce nessun entusiasmo che spinge a operare attivamente per la trasformazione del mondo. Non conosce speranza per un mondo migliore che dipenda dalla responsabilità dell’uomo. Chi vive nell’eternità non vive per il futuro. Dio è immutabile e anche i suoi effetti sono eterni. Immutabile è l’esserci dei modi infiniti, benché tutti i modi finiti mutano senza sosta nel permanere identico del tutto (Jaspers, trad. it., p. 180)[4].
Coerentemente con il suo impianto metafisico, Spinoza nega ogni Messia reale e ogni messianismo; lo stesso Cristo viene visto all’interno dell’ottica dello Spirito di Cristo e non come Cristo in persona, realtà concreta dell’uomo-Dio. Ho sottolineato in corsivo, invece, quella che potrebbe essere la posizione squisitamente jaspersiana su questa tematica così importante e sdrucciolevole.
È da notare, in prima battuta, quanto per il filosofo tedesco l’intero messianismo e, per estensione, la figura stessa del Messia, non siano realtà effettive ma cifre, ovverosia oggettività metafisiche che trovano pieno senso nel loro svanire. In secondo luogo, è doveroso porre maggior attenzione alla possibilità intrinsecamente umana di relazionarsi con dio: il messianico, in quanto cifra, in quanto evento escatologico, non può essere del tutto separato dall’agire umano. Qui il filosofo tedesco si rende conto di uno dei problemi più scottanti dell’intera questione del messianismo e cioè il giusto peso da assegnare alla responsabilità dell’uomo. Se in Küng, benché sia fatta chiara ed inequivocabile ammissione del messaggio di Gesù come avvento del Regno di Dio come mutamento radicale, conversione esistenziale, come vera e autentica «rigenerazione dell’uomo, compresa solo da chi concorre a realizzarla in prima persona»[5], si concentra tutta l’azione possibile nella totale «dedizione dell’uomo alla volontà di Dio»[6], in Jaspers, invece, è presente una reale forza dell’uomo che gli permette di incontrare Dio e stringere con lui alleanza: Συν-θήκη (sun-tzéke, appunto. Ancora una volta si percepisce quell’alone lontano della verità della religione biblica che ha nella nobilitas ingenita dell’esser-uomo uno dei suoi centri nevralgici. Qui si rende pienamente manifesta la profondità e la vastità di quell’intuizione che Jaspers non ha mai smesso di ripetere nei suoi numerosi scritti e che risale dal cuore della Bibbia: il Dio biblico non è antropomorfo, ma è l’uomo ad essere teomorfo, a immagine e somiglianza di Dio.
[1] H. Küng, Tornare a Gesù, Bur, Milano, 2014 p. 115. L’intero paragrafo è modellato a partire dalle intuizioni ivi espresse dal più grande teologo cattolico del dissenso.
[2] Ivi, p. 121.
[3] Ivi, p. 122.
[4] L’edizione a cui qui faccio riferimento, è quella curata da Giampaolo Bartoli, pubblicata dalla Castelvecchi nel 2015; corsivo mio.
[5] H. Küng, Tornare a Gesù, Bur, Milano 20142, p. 151.
[6] Ibidem.
@ILLUS. by PATRICIA MCBEAL, 2020