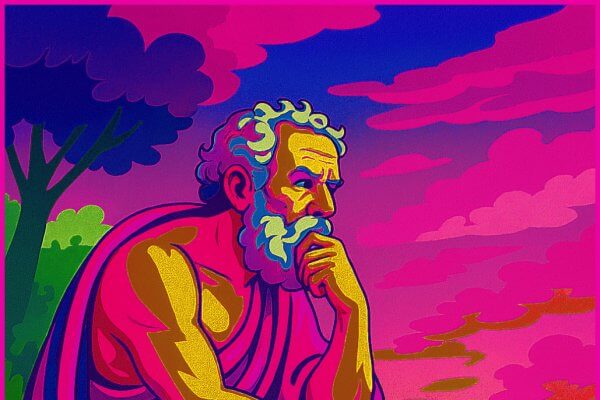IL FIGLIO SCABROSO: IL CRISTO-MOSTRO

«Vous mériteriez un châtimment, mais, je ne puis me résoudre à châtier les duex tiers de ma personne, car le tiers qui me reste soffriroit inocemment des fautes d’autrui, ainsi voilà donc, que mon essence s’oppose directement à ma justice»[1]
Vittorio Alfieri, Esquisse du Jugement Universel
Immaginiamoci la scena: Dio Padre che interviene per dirimere un diverbio, quasi fraterno, tra il Figlio e lo Spirito. Una bagatella familiare. Siamo nella Terza Sessione del Giudizio Universale. Lo Spirito Santo si sente messo in disparte: «non mi avete ancora dato la possibilità di giudicare e, mi pare, si tratta di una scortesia evidente». Riaffiorano vecchi dissapori, intradivini beninteso, che mettono a repentaglio il senso della Trinità: «ignoro ancora se devo chiamarvi padre mio, o meno». Già, la Trinità, la consustanzialità della pluri-unità divina (Padre-Figlio-Spirito Santo) pur nella diversità delle persone divine (Padre e Figlio e Spirito Santo). Il terzo giorno si giudicano le donne; se non fosse troppo stanco (e vecchio), lo farebbe volentieri il Padre (rigurgito giovenile?). Il Figlio no di certo: la carne è debole, e il Figlio di carne, volente o nolente, ne sa qualcosa. Lo Spirito ancora meno adatto: corruttibile con un po’ di miglio e due carezze (ricordiamocelo, è una colomba…). Giudicherà alla fine (della fine) le donne una donna, tabernacolo del mistero della donna: concedere la vita.
Alfieri era fondamentalmente un satirico illuminista; la sua salacità à la page denuda, però, un elemento universale: la scabrosità della Trinità. E ancor di più quella del Figlio (lasciando per ora in disparte lo Spirito Santo). Scabroso perché rende manifesta l’inumanità del Padre che ha permesso non solo che il Figlio unigenito si incarnasse, divenendo di fatto Figlio unigenito, ma anche che patisse le pene più atroci per chi, in fondo, non aveva chiesto nulla. Ma scabroso proprio perché in questa inumanità manifestata si cela la differenza ontologica più profonda: perché chiedere a Dio di essere umano? Eppure, che lo si sia chiesto o meno, Dio divenne umano. Il Figlio divenne figlio (di Maria e di Giuseppe), rimanendo però Dio, teofanicamente manifesto nell’ultimo atto, privilegio o condanna tutta umana, della morte. Con il Figlio non possiamo che tendere verso un consapevole «rapporto umano verso Gesù» (Jaspers), senza però dimenticarci della sua duplice natura di uomo-Dio.
Il Figlio è scabroso perché contemporaneamente uomo e Dio, uguale a noi in quanto uomo, ma differente, assolutamente e senza paragone, in quanto Dio. La giustizia di Dio non può contrapporsi alla sua essenza, vero; ma l’essenza stessa di Dio è di essere in-contraddittoria, di portare la contraddizione all’interno stesso dell’incontraddittorio per eccellenza. È l’annoso problema della contraddittorietà reciproca del Cristo storico e dell’Idea Christi: insomma, da una parte troppa incarnazione, dall’altra troppo poco incarnazione (Tilliette). Come affrontare allora la comparsa di Cristo? Come adeguare l’idea alla storia? Si deve propendere per il lato disincarnato? Ma Cristo è nato ed è morto, è vissuto e lo ha fatto nella storia. Ma la sua scabrosità estende la sua ombra lunga sul fluire stesso della storia: avanti Cristo e dopo Cristo. È la cesura del tempo, nel tempo, l’interruzione di una continuità nella sospensione del continuo e nell’instaurazione del discreto. Rottura e taglio netto (Sloterdijk). Insaturazione di tre tempi, il terzo dei quali virtuale e in-contraddittorio (contraddizione contratta nella sua sovrapposizione): Cristo è morto e vissuto nel dopo-Cristo: è morto nel 33 d. C., almeno secondo la tradizione, a 33 anni. Curioso che non sia spirato nel 66 d. C…. Qual è allora il tempo di Cristo? Altra scabrosa contraddizione: l’Idea Christi ha il suo tempo!
Siviglia, XVI secolo. Il russo Dostoevskij, per bocca del russo Ivan Karamazov, racconta al suo fratello russo Alëŝa, avatar di Dostoevskij, il progetto letterario del Grande Inquisitore. Un Cristo ritornato sulla terra e subito riconosciuto («(cosa strana!)», I fratelli Karamazov) viene catturato dal vecchio, siamo sulla novantina, Grande Inquisitore spagnolo che lo incarcera e lo interroga. «Perché dunque sei venuto a darci impaccio?», lo incalza. Come a dire, “hai fatto il tuo tempo, ora lascia fare noi”, noi che «abbiamo emendato le Tue gesta». La Storia si dimentica delle storie, o le lascia agonizzare; la Storia è «la strangolatrice» (la Sfinge) dell’Universale e faccenda umana, troppo umana. Emendare gli errori di Cristo: meno universale, meno divino; più umano, umano fino al midollo. Il Grande Inquisitore rimprovera al Cristo di essere stato troppo poco incarnato, di averci capito nulla di tutto ciò che umano: l’uomo non vive di solo pane, ovvio; ma se togli il pane, dell’uomo non resta che un corpo vuoto, involucro rattrappito. Più importante del cuore e del cervello è il ventre. Fine di tutto, l’obbedienza, venduta come libertà: assenso. Il Cristo ha lasciato all’uomo la libertà, ha scelto la libertà per l’uomo: Cristo si è confermato troppo Cristo, troppo Dio, troppo Idea Christi (la sua e quella degli altri). Solo Dio può essere libero; l’uomo si asserve all’assenso. Pegno della divinità del Cristo: libertà divina. La «debole schiatta sediziosa» teme la libertà; Quindici secoli dopo (come oggi venti) hanno decretato l’anacronia della libertà. Disturbo.
Il Cristo troppo umano del grido sofferente e disperato (“Dio mio, perché mi hai abbandonato”, traducibile in realtà con “Dio mio, perché mi hai sacrificato”, Garbini, Mito e storia nella Bibbia) confligge con il Cristo troppo divino della consapevolezza, precipitato ontologico della sua essenza, della Risurrezione: perché temere la morte se so che non morirò e che risorgerò? Nell’atto estremo, nell’estremità umana assoluta, sciogliente ogni legame, l’ancipite natura del Cristo subisce lo scossone decisivo. Aveva ragione il Grande Inquisitore? Il Cristo storico viene depredato dall’Idea Christi? Incarnazione imperfetta: divino troppo divino. Rivelazione, appunto, apocalittica. Necessariamente androcalittica? E ritorniamo così alla Idea del Cristo, cioè alla sua traduzione in Cristo ideale, non platonico, ma kantiano (il Buon Principio), o fichtiano (il Dottore della Scienza), all’Uomo-Dio, all’Uomo onestissimo e al summus philosophus spinoziano (elementi questi che si intersecano nella cristologia filosofica di Tiliette). Idea destinata a subire la contraddizione pratica della sua messa in azione: il Cristo della Storia sarà sempre l’eversione del e dall’Idea Christi. Dostoevskij questo lo aveva intuito.
Nell’intrico di universale e particolare, ma già per questo nel groviglio di Idea e Storia, il Cristo oscuro, figlio scabroso e dello scandalo, si manifesterà teocalitticamente e, forse, apo-androcalitticamente. Ma nell’assoluta umanità, Cristo ha sofferto disperatamente e ha avuto timore, una paura fottuta e umanamente comprensibile, della morte (Cullmann). Morte, del resto, che ha apo-teocalitticamente manifestato l’assurdità e la contraddittorietà del Cristo: Storia o Idea, Cristo è Mostro.
«Dunque, era necessario per questo e quello,
perché volevan segni che gridassero.
Ma lui sognava che a Marta e Maria bastasse
capire che poteva. Ma nessuno credeva,
tutti dicevano: Signore, che vieni a fare ormai?
E si avviò, per compiere sulla natura quieta
ciò che non è consentito»
È il Cristo incompreso di Rilke; quel mostro datore di vita oltre la morte (Risurrezione di Lazzaro). Il Cristo furioso, «[i]n collera», perché ha piegato l’impiegabile al desiderio quasi lubrico del mirabolante. La Realpolitik del Grande Inquisitore ha fatto effettivamente breccia; alla libertà l’uomo preferisce la schiavitù infiorettata dell’assenso, corroborata dal miracolismo prêt-à-porter. È un Cristo adirato e abbattuto, solitario tra la folla esultante ed esaltante. Un Cristo ramingo, cacciato, esorcizzato: «Va’, e non venire più… non venire più a nessun costo… mai, mai più!», invocazione liturgica del Grande Inquisitore.
E se ne va, negli «oscuri meandri della città», come il più terribile mostro perturbatore…
[1] «Voi meritereste un castigo, ma non posso risolvermi a punire i due terzi della mia persona, perché la terza [parte] che mi resta soffrirebbe, innocente, per le colpe altrui, in modo tale, dunque, che la mia essenza si opponga direttamente alla mia giustizia»
L’immagine in evidenza è una proiezione dell’opera di Max Ernst, Crocifisso, 1914, olio su tela, cm. 55 × 38, esposto ai Musei Vaticani
Il Cristo-mostro è un concetto presente nel lavoro congiunto filosofico-teologico di Žižek-Milbank in traduzione italiana di Bondi e Gonzi, La mostruosità di Cristo. Paradosso o dialettica?, Transeuropa, Massa 201o.
La citazione in esergo è tratta dall’edizione francese, con introduzione ed analisi in italiano di Guido Santato, Esquisse du Jugement Universel, Olschki, Firenze 2004.
Il riferimento a Jaspers è tratto dalla traduzione italiana di Filippo Costa, Socrate, Buddha, Confucio, Gesù. Le personalità decisive, Castelvecchi, Roma 2013.
Il testo di Tiliette è l’agile libricino nella traduzione di Giuliano Sansonetti, Che cos’è cristologia filosofica, Morcelliana, Brescia 2004.
Per il Cristo come cesura si legga di Sloterdijk, nella traduzione di Silvia Rodeschini, Dopo Dio, Raffaello Cortina, Milano 2018.
Di Dostoevskij si è citato dall’edizione italiana tradotta da Silvano Daniele, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino 2005, quarta edizione.
Di Giovanni Garbini si è fatto riferimento al testo Mito e storia nella Bibbia, Paideia, Brescia 2003.
Sul tema della morte di Cristo, si è consultato il volumetto di Cullmann, tradotto da Gallico, Immortalità dell’anima o risurrezione del morti?, Paideia, Brescia 1986, terza edizione.
Per la poesia di Rilke, si veda Risurrezione di Lazzaro, in Poesie sparse del secondo volume di Poesie (1907-1926), a cura di Andreina Lavagetto, Einaudi, Torino 2014, seconda edizione.
Per vedere tutti gli articoli di Cristologia portami via clicca qui.
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2019