L’ONTOLOGIA TECNO-ESTETICA DI GILBERT SIMONDON

Estratto da Gregorio Tenti, Estetica e morfologia in Gilbert Simondon, Mimesis 2020, pp. 76-81.
L’intuizione morfologica, per come si delinea in Simondon, sembra aprire ad una riconciliazione dell’estetica con sé stessa. […] [V]ige un legame inestricabile e fondamentale tra ciò che si produce come valore in sé, non sottomesso a fini esteriori, e ciò che invece è prodotto come mezzo. Simondon sembra rendersi ben conto da una parte dell’intimo rapporto tra la genesi del sentimento estetico e la natura del bisogno e del desiderio umano (tale che, ad esempio, l’arte è da sempre un’attività anche utilitaria[1]); e d’altra parte che la tecnica è in grado di vivificare un contesto culturale e naturale soltanto se mitigata da un impulso di ancoramento al senso, attraverso quella vita relazionale che traspare per l’appunto nell’attività estetica. L’estetico non può fare a meno del tecnico e il tecnico non può fare a meno dell’estetico, nel ricamo che lega entrambi al sacro. I due modi del fare umano convergono, di fatto e già da sempre, sia sul piano della fabbricazione degli oggetti che su quello della loro valorizzazione ed espansione realizzativa: come l’impulso estetico deve tecnicizzarsi, così la tecnica deve mostrarsi, enfatizzarsi, presentarsi, strutturarsi semanticamente.
Una cultura che si dispone come un sistema difensivo rispetto ai propri impulsi più radicalmente progressivi oblia le proprie tecniche e ne nasconde i ritrovati: la tecnica entra nella “cittadella” della cultura solo attraverso atti specifici di ritualizzazione, che ne controllano letteralmente l’apparizione. La sua legittimazione ha carattere estetico. Tale legittimazione non si aggiunge al fenomeno tecnico ma è coessenziale ad esso, nella misura in cui ne realizza il potenziale trasduttivo. Ai giorni nostri, la tecnica ha già raggiunto un grado di ecumenismo senza precedenti e opera stabilmente al livello dei grandi gruppi umani con un potere mitopoietico sempre maggiore: la tecnologia alimenta sempre e comunque l’immaginario archetipico di un gruppo sociale in maniera autonoma, diffonde da sé le proprie schematiche. È così che le reti tecniche di telecomunicazione, afferma Simondon, possiedono una necessità specifica e un’imponenza tali da richiedere e ispirare un atteggiamento partecipativo a livello trans-gruppale. Se questa produzione di senso venisse favorita, se si stabilisse cioè armonia tra cultura e tecnologia, l’estetica rifiorirebbe come mitologia, riacquistando “il posto centrale che occupava presso i Greci e che supera in maniera considerevole tutto ciò che è dell’ordine del gradimento e anche delle arti concepite come attività separata, cosa da artisti”[2].
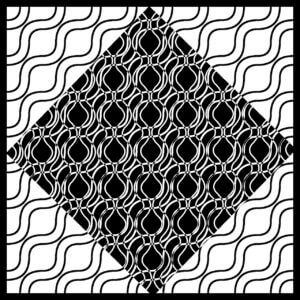
L’anello di giunzione tra esteticità e tecnicità resta indubbiamente una delle questioni più problematiche, almeno da quando nella tradizione moderna l’arte è stata definita in opposizione alla tecnica e al lavoro. Una prima serie di argomenti per confutare una impostazione rigidamente oppositiva in tal senso è rintracciabile nella storia materiale della cultura e dei saperi tecnici: non solo per lunghissimo tempo arte e tecnica sono state riunite sotto il concetto di un “saper fare”, un “sapere come” diverso da un “sapere che”; ma è possibile persino sostenere che tecnica, linguaggio ed estetica siano stati, nel processo di ominazione, tre aspetti di una medesima “tendenza all’esteriorizzazione” e alla “ritmicità”[3], alla ripetizione positiva, alla formula. Anche qualora si vedesse nel moderno una svolta radicale della storia dell’uomo, sarebbe difficile negare che lo sviluppo tecnico in età post-industriale è infine andato verso la costruzione di un ambiente integrato, non verso il dominio di un ambiente separato; non verso l’efficienza pura dei mezzi ma verso la comunicazione e la condivisione dei fini (pur con tutte le contraddizioni e le dinamiche di potere che sono oggi sotto i nostri occhi). La tecnologia non ha più innanzitutto a che fare con oggetti discreti e strumentalizzabili, bensì con reti più grandi tanto dell’individuo quanto del singolo gruppo. L’utopia simbolica che era stata affidata all’arte potrebbe essere passata di mano.
Abbiamo visto tuttavia come la tecnica partecipi già da sempre in misura fondamentale e per sua essenza al compito di valorizzazione del mondo. Occorre quindi partire da un’alleanza che sta al cuore pulsante dell’agire dell’uomo, piuttosto che da un divorzio storico. Tecnica e arte, prese in quanto tendenze essenziali (tecnicità ed esteticità), collaborano al gesto in cui consiste l’essere stesso: il gesto dell’“operazione riuscita”[4], della realizzazione continua che è l’effettività delle forme. Al contrario di quanto accade nel sacro, questo contatto con la virtualità relazionale “non si scioglie in nebbia”[5] ipostatizzandosi in un fondo separato e informe, ma va a costituire l’effettività delle forme e dell’essere stesso. In primo luogo, tecnica e arte sono quindi da riportare sul piano della fisica dell’essere.
Nella tradizione moderna, anche volendo attribuire all’uomo e alla natura un agire comune nel suo carattere poietico (ponendo dunque che si possa parlare di una technica naturalis), l’agire del primo consiste in un facere sostanzialmente demiurgico, mentre l’agire della seconda è un Wirken, un creare senza causa[6]. L’arte somiglia alla creazione dell’universo, ma nulla di più. Nel momento in cui però l’arte fa realmente come la natura, perde d’un colpo e necessariamente il suo carattere derivativo. L’analogia è un legame molto più stretto della similitudine. Per attraversare efficacemente il dualismo arte/tecnica, occorre dunque pensare fino in fondo l’analogia del facere con il Wirken. La poiesis non va intesa più come un’operazione lineare, passaggio dall’essere al non-essere come dalla causa determinante all’effetto determinato[7], dall’intemporale alla temporalità, ma in sé stessa come momento eterno che si ripete in ogni momento. L’istante genetico si colloca fuori dall’ordine della successione, senza che nulla preesista ad esso; non c’è in tal senso alcuna dinamica intenzionale o proairetica. La genesi è “l’organo centrale di ogni sommovimento spazio-temporale”[8], spontaneità di cause e dimensioni. Essa “si ripete” ogni volta assolutamente come genesi dell’essere, è ontologicamente ricorsiva, benché irreversibile. Non si può quindi supporre qualcosa come una genesi di tutte le cose, un’origine iniziale: l’essere è in ogni suo atto inaugurale, archè diffuso e fondamento vuoto, superficiale, ubiquo. Ancora una volta, una diversa metafisica della creazione opera lo spostamento da una morale che assegna la responsabilità di rispettare valori sempre precedenti ad un’etica in cui “l’atto s’identifica con l’essere”[9].
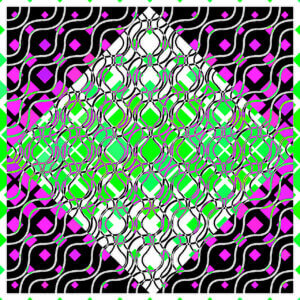
Nello stabilirsi di una reciprocità attuale delle forze si annulla il carattere di secondarietà dell’arte rispetto alla natura (quello per cui “der Mensch verdoppelt sich”[10]). L’arte non si struttura come ritrovamento, non possiede innanzitutto lo statuto storico della sopravvenienza. La natura dell’atto – Simondon ci si sofferma lungamente – mostra ragioni immanenti: è costruttiva nel senso della Wirken del reale. Comprendere l’essenza della cosa, l’intuizione, richiede da noi una forma di sapere costruttivo, è un “conoscere-facendo”[11]. Dino Formaggio porta l’esempio di Hermes che inventa la lira “vedendo” nella tartaruga morente la trasposizione del guscio in strumento musicale. Come sottolinea a sua volta Garroni[12], l’arte è costruttiva perché procede oltre la soddisfazione di un bisogno immediato, rivolgendosi alle relazioni pure: Hermes può fare ciò che prima non poteva, e che non saprà cosa è fino a che non lo fa per la prima volta, operando sullo spessore vivo della contingenza. L’artista “ulteriorizza il reale dato”[13] attualmente; è come un albero che riceve linfa e fiorisce in forme che non assomigliano in alcun modo alle sue radici: non prende la natura per data, ma la vede dal punto di vista della genesi[14].
L’oggetto ispira così un “io posso”, “un ‘può darsi’ che, attraverso la contingenza, si erge verso la potenza di una poiesis”[15]. Lo sguardo di Hermes coglie la datità secondo l’effettività (la Wirklicheit, che è legata al Wirken[16]). Tutto ciò è molto chiaro nel caso in cui gli oggetti sono trattati pragmaticamente come media e interfacce non feticizzati, non secondo essenze celate ma direttamente secondo l’ordine dei loro effetti. Uno scritto simondoniano molto tardo comincia proprio dichiarando che “è necessario tenere in considerazione in maniera privilegiata le interfacce”[17]. Si tratta di collocarsi in una dimensione in cui estetica e tecnica sono poste in uno “spettro continuo”[18], una vera e propria prospettiva “techno-esthétique”. Quando costruzioni tecniche come la Torre Eiffel o il viadotto di Garabit si impongono attraverso la propria presenza, catalizzando le forze dell’ambiente circostante, ritrovano la Terra su cui sono state costruite[19]. Ma anche uno strumento come una cesoia o una chiave a stella “risplende” della sua “naturalezza [aisance]”[20]: il suo uso può costituire un’esperienza estremamente potente e sfaccettata, poiché stabilisce una partecipazione con la porzione di mondo su cui si opera. Nell’atto di utilizzo è coinvolta la dimensione patica dell’utilizzatore, in cui è suscitato un piacere senso-motorio che è “quasi orgasmico”[21], perché indistintamente attivo e passivo, esperienza sinestetica della resistenza del reale e della sua trasformazione. “È come nel forgiare: ad ogni colpo di martello”, scrive Simondon, “si può esperire lo stato del metallo lavorato, che si estende e si deforma tra il martello e l’incudine. […] Il corpo dell’operatore dona e riceve”[22]. Non diversamente accade nell’esperienza dell’artista, così come in quella del fruitore, tramite cui una relazione operante è costantemente riattivata. Il movimento che anima un ritratto come la Gioconda è solo accennato nel dipinto (“vi è, sulla medesima e unica tela, l’inizio e la fine del sorriso, ma non il sorriso dispiegato”[23]): il sorriso attraversa la Gioconda come una faglia sotterranea, come la sua forza al contempo passata e a venire, eppure presente in maniera quasi immediata, come se il rappresentato vi fosse stato delicatamente sovra-impresso.
Analogamente, il bambino “non vede soltanto o non intende soltanto un’automobile”[24], ma fa egli stesso quello che fa l’automobile, ne recepisce gli schemi operativi, partecipa ad un funzionamento. Questa logica intuitiva si svolge nella presenza stessa delle cose, segue le forme come una “postura mutevole”[25], al contempo pre- e transindividuale, come un ingegno proteiforme. In tal senso la tecno-estetica costituisce una dimensione in cui l’aisthesis è già armonizzato con la sfera dell’agire produttivo, più originaria dunque rispetto all’estetica e alla tecnica prese in sé.
[1] “Non c’è altra arte se non quella utilitaria”, scrive Leroi-Gourhan. “Lo scettro, simbolo della potenza reale, il pastorale, bastone simbolico del vescovo, la canzone d’amore, l’inno patriottico, la statua che materializza il potere degli dèi, l’affresco che ricorda gli orrori dell’Inferno, rispondono a necessità pratiche indiscutibili. L’arbitrarietà non sta nelle cause ma nella fioritura del linguaggio delle forme” (A. Leroi-Gourhan, La memoria e i ritmi, cit., p. 422).
[2] G. Simondon, Psicosociologia della tecnicità, cit., p. 93.
[3] Cfr. A. Leroi-Gourhan, La memoria e i ritmi, cit., cap. XI.
[4] D. Formaggio, L’arte, il lavoro e le tecniche, in M. Dufrenne, D. Formaggio, Trattato di estetica, cit., p. 108.
[5] Ivi, p. 109.
[6] I. Kant, Kritik der Urteilskraft, §43. È forse utile ricordare che, all’interno della distinzione aristotelica tra praxis e poiesis, la vita (bios) appartiene alla sfera della praxis, quindi del processo orientato a sé stesso, che per l’appunto – come per Kant il Wirken della natura – non produce oggetti, ma ha effetti (cfr. Aristotele, Politica, I, 4, 1254 a 7).
[7] Ricordiamo la definizione platonica: “è poiesis ogni aitia [causa intenzionale] per cui qualcosa procede dal non-essere all’essere” (Platone, Simposio, 205 b-c).
[8] P. Klee, Über die moderne Kunst (1924), Benteli, Bern 1945, p. 47.
[9] G. Simondon, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione, cit., p. 771.
[10] G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Jubiläumsausgabe, Frommans, Stuttgart 1953, Band 12, I, p. 58. La natura, nota Heidegger, è sempre considerata come “ciò che viene prima” (cfr. M. Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della physis, cit., p. 195).
[11] D. Formaggio, L’arte, il lavoro e le tecniche, cit., p. 106.
[12] E. Garroni, Creatività, Quodlibet 2010, pp. 176 e sgg.
[13] D. Formaggio, L’arte, il lavoro e le tecniche, cit., p. 110.
[14] Cfr. P. Klee, Über die moderne Kunst, cit., pp. 11-15.
[15] M. Dufrenne, Arte e natura, cit., p. 43.
[16] Sulla categoria di “effettività” (Wirklichkeit) cfr., oltre alla celebre querelle Kant-Hegel, N. Hartmann, Possibilità ed Effettività, Mimesis, Milano-Udine 2018.
[17] G. Simondon, Riflessioni sulla tecno-estetica, cit., p. 320.
[18] Ivi, p. 324.
[19] Cfr. l’uso della nozione di “Terra” in M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Holzwege, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2014. Simondon ha descritto altrove il momento in cui le costruzioni tecniche, come la torre o il ponte, “si inseriscono in una rete che copra la Terra intera con i suoi nodi, in accordo con le strutture geografiche e le possibilità viventi di questa Terra” (G. Simondon, La mentalità tecnica, in Id., Sulla tecnica, cit., p. 264). Nella distinzione operata da Derrida, occorrerebbe avvicinare questo concetto del “Luogo” più alla consacrazione di un “alto luogo” pagano che alla “promessa” escatologica dell’origine (cfr. J. Derrida, La scrittura e la differenza, cit., p. 186).
[20] G. Simondon, Riflessioni sulla tecno-estetica, cit., p. 322 (trad. leggermente modificata).
[21] Ivi, p. 323.
[22] Ibidem.
[23] Ivi, p. 325.
[24] G. Simondon, Psicosociologia della tecnicità, cit., p. 27.
[25] G. Simondon, Riflessioni sulla tecno-estetica, cit., p. 333.
Per vedere tutti gli articoli di Tecnica-mente, clicca qui
@ILLUS. NEL CORPO DEL TESTO by FRANCENSTEIN & G.E.O.M, 2022
ESTETICA E MORFOLOGIA IN GILBERT SIMONDON







