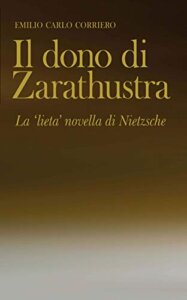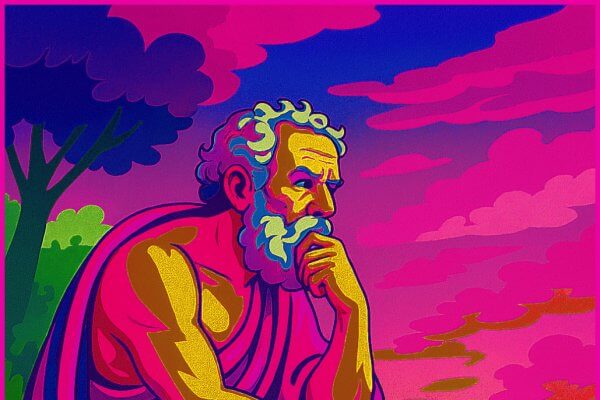IL DONO DI ZARATHUSTRA

Estratto da Il dono di Zarathustra. La «lieta» novella di Nietzsche di Emilio Carlo Corriero
Rispetto al dono della tradizione cristiana, che si annuncia anzitutto come dono (d’amore) di Dio agli uomini i quali devono restituire in uno sforzo infinito rimanendo all’interno dell’amore di Dio […], il dono di Zarathustra non dipende da un donatore originario – Zarathustra stesso è un semplice mediatore –, e la sua forza e il suo potere dipendono dal dono stesso. Ciò non toglie che però il dono di Zarathustra continua a vincolare alla ‘restituzione’; il dono di saggezza non è affatto slegato dalla relazione tra donatore e donatario, semplicemente la relazione viene rivoluzionata alla luce della specificità del dono e della sua dinamica.
La saggezza che viene donandosi, mediante Zarathustra, impone a chi l’accoglie un’adeguata risposta la cui norma è inscritta nella saggezza stessa che avanza. Il dono ‘scandalizza’ comunque, tuttavia non perché il donatario debba sentirsi in obbligo nei confronti del profeta Zarathustra, che letteralmente porta la parola ‘di altri’ (o meglio sarebbe dire, ‘d’altro’) e si fa semplice mediatore; l’obbligo della restituzione che il dono impone deriva non dall’auctoritas da cui proviene, ma proprio dall’assenza di tale auctoritas separata. La saggezza che ora va donando viene a Zarathustra del tutto gratuitamente come emersione in superficie di un comune sapere, di un’appartenenza che ci vincola da sempre alla totalità. Ancor più cogente è dunque quest’obbligo rispetto a un obbligo contratto con un Dio a cui mai potremmo fino in fondo corrispondere in maniera adeguata.
Il dono di Zarathustra è in fondo una voce che avvertiamo già da sempre dentro di noi, ed è la voce che ci comunica la nostra radice comune, la nostra comune provenienza che ci lega alla totalità ed è capace di ri-legare, di riallineare il volere egoistico al volere universale verso il nostro comune destino, secondo un pensiero che presenta una chiara eco emersoniana e rimanda ai primissimi scritti filosofici di Nietzsche[1], ma che nella filosofia matura di Nietzsche si chiarisce come tensione inesausta all’Oltreuomo, inteso quale alternativa al destino nichilistico passivo dell’‘ultimo uomo’. Con la ‘morte di Dio’ si apre di fatto un’alternativa netta e senza mediazioni tra un destino che continua il declinare disperato che ha condotto all’esaurimento dell’ipotesi di Dio, che pure per secoli ha assolto la sua funzione di vincolo comunitario (nel senso più alto e più ampio dell’espressione), e la scelta per un nichilismo attivo che prende atto dell’assenza di fondamenti ultimi e decide il destino all’insegna del superamento del disperato declinare a cui sembra consegnato l’essere nell’epoca della ‘morte di Dio’. Questa decisione passa per l’accettazione di un nuovo amore affermativo che soppianta l’amore dei compassionevoli e intende consegnare ogni frammento disperso alla totalità da cui si è separato. È a partire da qui che risulta possibile ricavare la comprensione di quelle perentorie esortazioni al nuovo amore che si leggono nel § 4 del Proemio e che fuori da tale contesto teorico risultano contraddittorie e paradossali:
Quel che è grande nell’uomo è che egli è un ponte e non un fine: quel che si può amare nell’uomo è che egli è un passaggio e un trapasso.
[…]
Amo colui la cui anima si dissipa, che non vuole ringraziamenti e che non restituisce: giacché egli dona sempre e non vuole conservarsi.
[…]
Amo colui la cui anima è stracolma, sicché dimentica se stesso, e tutte le cose sono in lui: così tutte le cose diventano la sua fine (KSA, IV, pp. 16-18)[2]
Questa articolata professione di amore pronunciata da Zarathustra con un evidente richiamo alle Beatitudini[3] si apre con una premessa che anticipa e riassume ogni asserzione successiva. L’amore per l’uomo che Zarathustra professa è un amore volto anzitutto a liberare l’uomo da se stesso, dalla sua soggettivazione, dalla gabbia della finitudine entro la quale aveva trovato conforto quale canale privilegiato per il contatto con il Dio a cui rendere grazie. Tra gli effetti del cristianesimo contro cui intende dirigere l’amore portato in dono da Zarathustra v’è infatti l’esasperazione della soggettività che a partire dalla mediazione dell’assoluto operata dal Cristo-uomo conduce nella modernità, in un inestricabile intreccio con il processo di secolarizzazione, a un’esasperazione del valore assegnato al singolo e a forme di religiosità intimistiche che finiscono per negare il senso stesso della religione, intesa come re-legere, tenere assieme.
Paradossale effetto del cristianesimo frainteso è infatti il potenziamento del soggetto: si pensi all’atteggiamento spavaldo di quanti ascoltano sulla piazza del mercato, saldi nelle loro convinzioni, nella loro ‘soggettività’, nell’illusione di essere al riparo dal crollo, il folle che annuncia la ‘morte di Dio’. Chi pretende di comprendere l’Oltreuomo come il potenziamento dell’individuo non afferra la proposta alternativa a tale destino di declino che invece avanza Nietzsche. Anziché il potenziamento dell’individuo, l’Oltreuomo prefigura l’abbandono dell’individualità; ciò che è degno d’amore nell’uomo non è la sua capacità di potenziarsi, ma semmai la sua capacità di dismettere quella potenza, di rinunciare a farsi fine per divenire mezzo del superamento. Ciò che è degno d’amore nell’uomo è la sua capacità di ‘distaccarsi’ da sé, di svuotarsi della propria potenza di sé (o meglio di questa illusione) e di prendere (la giusta) ‘distanza’, di esonerarsi dall’ambiente in cui è immerso e dagli impulsi che gli provengono[4]
[…]
Con la figura del dio fattosi uomo e con l’amore che accompagna questa particolare ‘donazione’, il cristianesimo si avviò certamente sulla strada che conduce al superamento delle distinzioni, ma rimase prigioniero della separazione metafisica sulla quale si fondava e delle costruzioni teologiche che su di essa vennero edificate determinando progressivamente, per un verso, l’insignificanza dell’ipotesi di Dio e dunque la sua ‘morte’ storica e, per l’altro, il potenziamento della soggettività la quale, nutrendosi della separazione metafisica, accumulò in sé quel valore attribuito e assegnato un tempo fuori di sé, presso Dio.
Il fatto che Dio è diventato uomo – osservava il giovane Nietzsche in Libertà della volontà e fato – non fa che ricordarci che l’uomo non deve ricercare la sua beatitudine nell’infinito, bensì deve fondare sulla terra il suo paradiso[5] [grassettatura opera del redattore dell’articolo].
È certamente paradossale, ma tra gli effetti di questo passaggio decisivo compiuto dal cristianesimo che mostra Dio farsi uomo, v’è il lato opposto della medaglia: è l’uomo a essersi fatto Dio. Non abolendo la distinzione originaria tra mondo ideale e mondo reale, l’uomo si illude di (ri-)appropriarsi di quegli attributi che aveva riservato a Dio, e non afferra l’autentico messaggio, che secondo Nietzsche sarebbe alla base della legge d’amore dei vangeli. Come egli stesso mostra molti anni dopo in un passo decisivo de L’Anticristo, l’amore dei vangeli mira infatti alla realizzazione della beatitudine direttamente “sulla terra” passando per il superamento di ogni distinzione, inclusa ovviamente la distinzione fondamentale tra ‘mondo vero’ e ‘mondo apparente’:
L’incapacità di resistere diventa qui moralità («non contrastare al male!» sono le più profonde parole dei Vangeli, in un certo senso la loro chiave), lo diventa la beatitudine nella pace, nella mitezza, nel non-poter– esser-nemici. Che cosa significa «lieta novella»? la vita vera, la vita eterna è trovata, – non viene promessa, esiste, è in voi: come vita nell’amore, nell’amore senza detrazioni o esclusioni, senza distanza (KSA, VI, p. 200)[6].
[…]
Tuttavia, l’amore dei vangeli, secondo Nietzsche, non è di per sé sufficiente a compiere il superamento e infatti conduce per un verso all’indifferenza nichilistica e per l’altro all’esaltazione dell’individualità. Con il suo ‘quinto evangelo’, Nietzsche ritiene di poter compiere quel “passo decisivo” nella direzione già segnata dall’amore dei vangeli, capace di superare le secche in cui il cristianesimo storico ha condotto. L’amore dei vangeli deve essere integrato da una dinamica attiva, che sia capace di (ri)costituirlo dall’interno come infinita volontà affermativa di creare, di ‘donare senso’ laddove il senso è smarrito e abbandonato a un perpetuo declinare.

[1] «La volontà libera – scrive Nietzsche in Fato e storia – appare come ciò che non conosce catene, che è arbitrario; è l’infinitamente libero, avventuroso, lo spirito. Ma il fato […] è la forza infinita della resistenza contro la libera volontà; una volontà libera senza fato è tanto impensabile quanto lo spirito senza la realtà, il bene senza il male. Perché a fare una qualità occorre l’opposto […], la volontà libera non è nient’altro che il potenziamento supremo del fato», F. Nietzsche, Scritti giovanili, 1856-1864, trad. it. a cura di M. Carpitella, Milano, Adelphi, 1998, p. 209.
[2] F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Proemio.
[3] Cfr. in generale il Discorso della montagna in Matteo (Mt 5, 1-48), ma anche il cosiddetto ‘discorso della pianura’ di Luca (in particolare Lc 6, 20-45).
[4] Le riflessioni della successiva antropologia filosofica, in particolare di Scheler e di Gehlen, devono molto a Nietzsche e a loro volta risultano illuminanti per questo passaggio del suo pensiero.
[5] F. Nietzsche, Scritti giovanili, 1856-1864 cit., p. 213.
[6] F. Nietzsche, L’Anticristo, § 29.
Emilio Carlo Corriero – Università di Torino, dipartimento di Filosofia e Scienza dell’Educazione
Per vedere tutti gli articoli de Essere nichilista, clicca qui.
@ILLUS. IN EVIDENZA, by FRANCENSTEIN, 2020
@ILLUS. IN FONDO AL TESTO, by PATRICIA MCBEAL, 2020
IL DONO DI ZARATHUSTRA