IL CRISTO DI DIO: L’IPOTESI BINITISTA

Riflettere sull’origine del cristianesimo, sulla nascita del cristianesimo dalla sua matrice giudaica è sempre molto delicato, consapevoli del fatto che tale «metafora biologica» (Norelli, La nascita del cristianesimo) non riesca a fornire un quadro completo del suo sbocciare. Difatti, quando se ne parla sia come movimento religioso, che come insorgenza storica innovativa, non si può non constatare quanto la novità sia profondamente radicata nella tradizione da cui si distacca. Si deve, pertanto, tenere presente che l’inizio del cristianesimo, la sua innovazione rispetto al sostrato nel quale ha giaciuto in incubazione, è successivo alla sua origine. A complicare ulteriormente la questione è il fatto che con il termine ‘cristianesimo’ si devono affrontare due differenti origini: la prima, riguardante la persona su cui si è fondato il cristianesimo, cioè Gesù di Nazareth; la seconda in riferimento alla formazione di un assetto religioso differenziato dall’alveo giudaico da cui ha comunque tratto linfa vitale. Qui ci soffermeremo principalmente sulla figura di Gesù presentando l’ipotesi storico-teologica del professore Larry W. Hurtado e definita binitismo.
Si è Gesù presentato come messia? Come è stato possibile che un uomo sia divenuto non messaggero divino, non profeta di Dio, bensì incarnazione di Dio, ovverosia uomo-Dio? Come è possibile che Gesù sia divenuto il Cristo? Quando si incominciò a venerare la figura di Gesù come quella del Cristo? Bisogna spostare la data in avanti, cioè dopo le esperienze delle prime comunità costituite da discepoli e da pochi credenti giudaici, oppure è necessario tornare indietro fino ai primi anni, per non dire alle prime settimane, dopo la morte in croce di Gesù di Nazareth? E che cosa significa, allora, elevare la figura di un uomo, quale quella di Gesù, allo statuto ontologico di divinità?
Se si analizzano gli scritti giudaici tra il III secolo prima di Cristo e il I successivo alla sua nascita, si possono riscontrare numerose presenze di entità che abbiano assunto uno statuto ontologico singolare, specialmente in riferimento a JHWH; non si tratta di forme divinizzate di esseri umani, né di apoteosi eroica, ma di figure esaltate, superiori, di intermediari prediletti tra l’uomo e Dio: i cosiddetti agenti principali. In Come Gesù divenne Dio, Larry W. Hurtado si è soffermato con particolare attenzione proprio sulla specificità della venerazione nei confronti Gesù, ora elevato a Cristo, ponendola in confronto con le abituali pratiche cultuali del giudaismo del secondo tempio coevo. La straordinarietà rilevata è di carattere cultuale: al Dio unico che si è rivelato al popolo eletto costituendolo, si è affiancata una figura altrettanto divina e non un semplice intermediario né una figura angelica, ma una divinità parigrado. Molto probabilmente l’accusa di diteismo, cioè credere in due divinità principali, si abbatté su questi credenti della prima ora. Tuttavia, è lecito chiedersi: invocavano realmente il nome di Gesù come se fosse stato una divinità altra, giustapposta e necessariamente contrapposta all’unico Dio d’Israele? Era davvero un superamento del rigido monoteismo giudaico? Tuttavia, i primi giudei che credevano nell’elevazione di Gesù a divinità non si sentivano politeisti o diteisti, anzi; e siccome nel culto era racchiusa la peculiarità non solamente del credo religioso ebraico, ma dell’intero popolo, il credere in Cristo, secondo Hurtado, rappresentava l’avvenuta presa di coscienza del compimento delle promesse che Dio aveva rivolte al suo popolo eletto. L’affiancare una figura divina a JHWH, lungi dal pregiudicarne l’esclusività assoluta e trascendente, valorizzerebbe, pertanto, ulteriormente la fedeltà di Dio verso il suo popolo eletto nella realizzazione delle sue promesse con l’invio del Messia.
Ed è proprio a partire dalla centralità del culto che si sostanzia l’ipotesi binitista: dal momento che in esso si concretava l’esperienza religiosa ebraica e, per così dire, si trovava la giustificazione all’elezione del popolo di Israele, l’affiancamento nella prassi cultuale a Dio di una seconda divinità non doveva essere valutata, da coloro che la professavano, come un’indebita intrusione diteistico-politeistica, ma come una evoluzione del monoteismo giudaico in sostanziale continuità con la tradizione del giudaismo del secondo tempio. Il Dio protocristiano (ovvero non pienamente dispiegato) si è presentato, fin da subito, binario: non due divinità distinte, ma l’unica divinità, l’autentico JHWH che ha realizzato le sue promesse in Gesù, ora Cristo. Dio non è stato sdoppiato, né si è attentato alla sua unicità, ma si è approfondito ulteriormente il legame di elezione con il suo popolo nell’invio di Cristo, egli stesso Dio. La pratica devozionale e la venerazione di Gesù in quanto Signore, per coloro che hanno riconosciuto in Gesù il Cristo di Dio, era, allora, perfettamente giustificata e santificata dal fatto che era coerente con il volere di Dio, cha lo ha esaltato, attraverso la morte, «alla gloria e allo status unico di “signore”» (Hurtado, Come Gesù divenne Dio).
L’ipotesi è molto suggestiva ma presenta un aspetto decisamente critico che potrebbe inficiarne i risultati: l’argomentazione è viziata da una neanche troppo latente petitio principii. Ovverosia, l’intero discorso sembrerebbe volto a giustificare razionalmente e presentare come conclusione della ricerca il punto di partenza stessa. Difatti, a sostegno dell’impianto teorico riguardante la divinità del Cristo, viene richiamata l’attenzione sull’esplosività di esperienze religiose innovative a seguito di rivelazioni divine (o presunte tali). Insomma, per dimostrare la credenza precoce nella divinità del Cristo, e di conseguenza della sua rivelazione, si porta come prova la rivelazione che deve essere provata! Poco probante, in poche parole. Tale metodo può però fornire un ottimo criterio ermeneutico grazie al quale affrontare il dilemma dell’ipostatizzazione (divinizzazione) di Gesù a Cristo. E l’inconseguenza logica all’interno della quale è racchiuso il discorso di Hurtado ci apre ad ulteriori domande estremamente stimolanti: deve essere il discorso teologico necessariamente ontologico? Cioè teo-onto-logico?
L’immagine in evidenza è una rilettura di Masaccio, Crocifissione, 1426, tempera su tavola, cm. 83 × 63, pannello (centrale) del polittico di Pisa (disperso), conservato presso il Museo di Capodimonte, Napoli.
Di Enrico Norelli si è fatto riferimento al suo La nascita del cristianesimo, Il Mulino, Bologna 2014.
Per il testo di Hurtado si è consultata la traduzione italiana di Angelo Fracchia, Come Gesù divenne Dio, Paideia, Brescia 2010.
Per vedere tutti gli articoli di Cristologia portami via clicca qui.
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2019




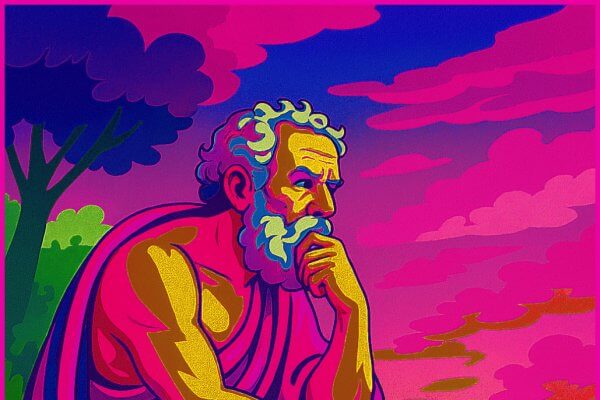


La petitio principii non è un vizio: si può dire che la filosofia sia la ricerca del giusto presupposto. Tuttavia molte argomentazioni sono insostenibili perché, appunto, vengono meno ai propri assunti già cercando di farne convivere due, inconciliabili, nello stesso discorso. Quello dell’Unità di Dio è un principio totalizzante, intollerante di ogni altro principio, poiché il Dio che è Uno, per rimanere tale, o fa già da sempre propria tutta l’esistenza o si riduce a un principio assiologico fatto solo di sé stesso privo di qualsivoglia attributo. Poiché ogni Suo attributo sarebbe un ulteriore Dio dovendo differire dall’essenza di Questo. Per altro in quest’ottica Dio dovrebbe ignorare ogni faccenda mondana, nonché sé stesso, poiché anche la conoscenza che Dio ha di sé ne sarebbe un attributo. E questo è un Dio cieco, impotente, morto, non compatibile con le vedute dei cristiani.
Dunque se il cristianesimo vuole scansarsi da tali speculazioni, è l’Unità di Dio che deve sacrificare, la sua scienza, la sua perfezione e la sua eternità, confidando in divinità mortali, super-enti plurali, patroni e santi che condividono le proprie sorti con quelle degli uomini cercando di riemergere dalle sabbie mobili degli abissi della potenza.
Capisco il tuo punto di vista, Gastone, e lo condivido. Tuttavia, il rischio è quello di ricadere in un tutto che è Dio, in uno sprofondarsi del Tutto in Dio, diventando il Tutto una parte di Dio che, essendo il Tutto, non dovrebbe concettualmente conoscere parti. Assisteremmo ad una messa in abisso del Tutto che avrebbe al suo interno tanti Tutti (le tue divinità alle quali ti riferivi)!
Ti ringrazio per il commento ché molto preciso e mai banale e permette di approfondire una tematica decisamente interessante e feconda!
Infatti delle due letture da me paventate opto per la seconda. Tuttavia quell’arché che è anche telos e morte ontologica non è Dio, ma la negatività in cui gli Dei, gli uomini e le cose tutte si muovono. Lo sprofondare degli Dei è occasione per la riemersione di altri Dei.
Chiaro. Una prospettiva per la quale il negativo si presenta come innervamento della molteplicità (l’aspetto politeistico) all’interno della non positività (perché positività sarebbe negatività della negatività e, in parte, dialettica) e della non negatività. Una prospettiva teologica forte, anzi fortissimamente sovrateologica! Davvero molto interessante!