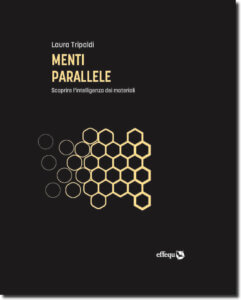STRUTTURE INORGANICHE E ORGANISMI VIVENTI SPONTANEI

Estratto da Menti parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali, di Laura Tripaldi, Effequ, 2020.
Il modo in cui un insieme di oggetti semplici interagisce per formare una struttura complessa è uno degli aspetti più affascinanti della materia che ci circonda. Come esseri umani, siamo da sempre in grado di assemblare componenti materiali per costruire oggetti artificiali capaci di svolgere differenti funzioni; la nostra capacità di costruire macchine e strutture è sorprendente, ma il modo in cui trasformiamo la materia intorno a noi non regge in alcun modo il confronto con i processi di assemblaggio della natura, in particolare quelli che caratterizzano la materia vivente. Come fa una pianta a crescere? Come si forma un diamante? Perché dobbiamo fare moltissima fatica per progettare, costruire e riparare le nostre macchine, mentre gli organismi che ci circondano, così come i nostri stessi corpi, sono capaci di farlo inconsapevolmente e in totale autonomia? La distanza che separa le nostre tecnologie dagli organismi naturali sembra un abisso incolmabile, che ci divide da un paradiso perduto di abbondanza infinita e rigenerazione eterna.

La parola chiave è spontaneità: quello che ci colpisce, quando guardiamo crescere un organismo vivente o osserviamo la perfetta simmetria di un cristallo, non è tanto la sua forma o la sua funzione, ma il modo in cui queste strutture macroscopiche emergono autonomamente dal basso, utilizzando gli ingredienti chimici presenti nell’ambiente per dare forma a un ordine superiore. Diversamente, la maggior parte delle strutture artificiali è costruita dall’uomo con un approccio che potremmo definire verticale, in cui un progetto precostituito ed esterno dirige dall’alto l’assemblaggio delle singole componenti materiali per produrre un determinato oggetto. Nei processi naturali di assemblaggio, invece, non esiste progettualità, o, se esiste, si tratta di una progettualità completamente interna al sistema fisico che ne è il prodotto. La spontaneità è un concetto intuitivo, ma non banale dal punto di vista fisico. Nel linguaggio comune la spontaneità ha a che fare con la possibilità di un soggetto di autodeterminarsi, cioè di agire senza essere controllato dall’esterno: una persona è spontanea quando il suo comportamento riflette in modo autentico il suo stato emotivo interiore, ad esempio quando ride o si commuove senza sentirsi obbligata da particolari regole sociali ad assumere un certo atteggiamento. Nel linguaggio scientifico, invece, il concetto di spontaneità ci parla di come un sistema o un fenomeno fisico gestisce il proprio bilancio energetico in relazione con l’ambiente che lo circonda: un sistema attraversa una trasformazione spontanea quando avviene una trasformazione senza che una forza esterna agisca su di esso spendendo energia.
Quella della spontaneità è una questione che ci riguarda molto da vicino. Il nostro organismo non è stato costruito una molecola alla volta, ma le strutture biochimiche che ci compongono si sono formate e continuano a riformarsi in autonomia, utilizzando la materia che assorbiamo dall’ambiente per assemblare in modo spontaneo i nostri corpi. Se immaginiamo di prendere una qualsiasi macchina rotta, ad esempio un’automobile o una lavatrice, e di “nutrirla” con un frullato delle sostanze che la costituiscono, questa non sarà mai capace di autorigenerare nemmeno la più piccola parte della sua struttura. Ciò avviene perché le relazioni tra le parti che compongono le macchine artificiali – o almeno le macchine come sono convenzionalmente intese – non sono intrinseche, non sono cioè spontanee, ma sono imposte dall’esterno al momento della loro costruzione, ed esistono, se così si può dire, su un piano separato rispetto alla materia di cui la macchina è composta. Ma è possibile immaginare una macchina artificiale capace di crescere, riprodursi e rigenerarsi allo stesso modo del nostro corpo?
Il confronto tra un organismo vivente e una macchina può apparire abbastanza inclemente. Si tratta di due tipi di sistemi che sembrano rispondere a leggi fisiche completamente diverse: mentre l’organismo cresce e si rigenera, la macchina, così come siamo abituati a concepirla, senza l’intervento umano non sa fare altro che aspettare di disintegrarsi, assecondando l’effetto del ben noto principio termodinamico che porta ogni sistema isolato ad accrescere il proprio ‘disordine’ interno. Seguendo un approccio animistico potremmo pensare che gli organismi viventi possiedano una qualità immateriale che li rende diversi da tutto il resto della materia che li circonda, che permette loro di procedere nella direzione opposta al flusso impietoso del tempo. Per un lungo periodo si pensò che le leggi della termodinamica non fossero sufficienti a giustificare la fisica dei processi di crescita e differenziazione che si manifestavano negli organismi viventi; in particolare, gli embrioni sembravano rispondere a princìpi di differenziazione e organizzazione spontanea della materia che apparivano del tutto incompatibili con le conoscenze della fisica del tempo. L’embriologo Hans Driesch, vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, fu uno degli ultimi esponenti della corrente di pensiero conosciuta come vitalismo, secondo cui l’organizzazione degli organismi viventi non poteva essere spiegata facendo esclusivamente ricorso alle leggi della fisica. Osservando la capacità degli embrioni del riccio di mare di produrre un intero organismo adulto anche quando veniva diviso a metà, Driesch giunse alla conclusione che la materia vivente doveva essere animata da un principio immateriale capace di dirigerne lo sviluppo, che definì facendo ricorso al termine aristotelico entelechia[1]
In realtà le leggi che governano l’organizzazione dei sistemi viventi e quelle che determinano la disintegrazione dei sistemi artificiali sono esattamente le stesse, e non c’è nessuna forza misteriosa che permette alla materia vivente di organizzarsi in autonomia. Questa realizzazione ci impone di chiederci perché gli stessi princìpi fisici possano condurre a risultati apparentemente opposti. La differenza tra le macchine ordinarie e gli organismi viventi risiede nella loro diversa architettura: mentre le macchine sono generalmente costruite seguendo un approccio top-down (dall’alto al basso), cioè sono assemblate da un agente esterno a partire da un progetto preformato della loro struttura, i sistemi viventi si formano seguendo un processo bottom-up (dal basso all’alto), cioè emergono spontaneamente dall’interazione continua e dinamica delle parti che li compongono.
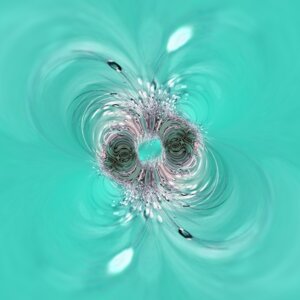
Il carattere quasi miracoloso della trasformazione spontanea dal disordine della materia inorganica all’ordine degli organismi viventi è esemplificato molto bene dai miti di creazione, nei quali il creatore o demiurgo costruisce un organismo perfettamente funzionante a partire dall’argilla o dalla polvere. In questi miti è spesso il soffio divino, una forza spirituale e immateriale simile all’entelechia dei vitalisti, che permette la transizione della materia da una configurazione completamente disorganizzata a una struttura ordinata. La materia che compone la polvere e quella che compone l’organismo sono esattamente le stesse; la differenza essenziale è nella loro organizzazione. Al di là della prospettiva religiosa, la scienza si è interrogata molte volte su una domanda simile, cioè su come sia stato possibile che la vita biologica abbia preso forma a partire da un ‘brodo’ di ingredienti chimici disorganizzati all’origine. Trovare una risposta a questa domanda non ci permetterebbe soltanto di comprendere la nostra storia – di capire una volta per tutte da dove veniamo – ma ci può aiutare a capire se, e a quali condizioni, altre organizzazioni materiali, naturali o artificiali, terrestri o extraterrestri, possano essere considerate a loro volta viventi. Spostando l’attenzione dalle specifiche sostanze chimiche che costituiscono il corpo di un essere vivente alla struttura che le connette, un giorno potremmo essere in grado di costruire tecnologie artificiali capaci di crescere e replicarsi come veri e propri organismi. La vita stessa, se svincolata dalla sua definizione più stringente, potrebbe essere un fenomeno più diffuso nell’universo di quello che pensiamo: strutture materiali capaci di organizzarsi spontaneamente, chimicamente diversissime da noi, potrebbero nuotare nei mari di metano liquido che ricoprono la superficie di Titano o volteggiare tra le nubi acide dell’atmosfera di Venere.
Nella tradizione mistica ebraica, la possibilità di riprodurre artificialmente il processo di creazione è concretizzata nella figura del golem, un organismo antropomorfo capace di auto-assemblarsi dalla polvere al comando di un essere umano. Nei racconti degli antichi cabalisti, la forza organizzante che permette al golem di mantenere la propria configurazione umana, e che lo mantiene almeno all’apparenza vivente nonostante le spinte naturali che lo porterebbero alla disgregazione, è una parola magica tracciata sulla sua fronte: la parola ebraica ‘emet, verità (più letteralmente: ciò che è stabile e fermo, quindi vero[2]). Quando l’organismo ha esaurito la propria funzione, o inizia a sfuggire al controllo del suo creatore, è sufficiente cancellare la parola dalla fronte del golem per ridurlo di nuovo al cumulo di materia da cui è emerso.
Quello che trovo particolarmente affascinante, nella mitologia del golem, è che il suo processo di creazione e dissoluzione mette in luce la connessione, espressa in forma magica e occulta, tra materia e informazione. Qui l’idea animistica del soffio vitale è rimpiazzata da qualcosa che, pur restando immateriale, è ben più definito e concreto: è la parola, cioè una “stringa” di informazione, che permette alla materia di organizzarsi secondo una particolare struttura. Al contrario di un principio trascendente, però, la parola magica del Golem è inscritta nella polvere che lo compone, e non può essere separata dalla creatura che anima senza che questa venga disintegrata del tutto. Può essere interessante pensare che, nel moderno ebraico, la parola golem significa anche robot: questi due organismi, uno mitologico e l’altro tecnologico, hanno molto in comune, perché sono entrambi corpi artificiali antropomorfi capaci di obbedire ai comandi di un essere umano, ma sono anche molto diversi, perché se il Golem è capace di auto-organizzarsi spontaneamente il robot è invece assemblato dall’uomo un pezzo alla volta. Tuttavia, se si pensa alla robotica soft di cui abbiamo parlato poco fa, che sfrutta la capacità di auto-organizzazione spontanea delle diverse componenti di un sistema, possiamo intuire che possono esistere approcci alla costruzione di automi che sono molto più simili al mito del Golem di quanto non possa sembrare.
Ai giorni nostri, la formalizzazione del misterioso rapporto tra organizzazione materiale e informazione non è più soltanto un argomento riservato a occultisti e stregoni impegnati a incidere parole magiche su statue d’argilla, ma è al cuore dello studio di quelli che sono stati definiti, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, sistemi complessi. Nel contesto delle scienze naturali un sistema complesso, ad esempio un organismo vivente, è un sistema fisico costituto da una molteplicità di componenti in continua interazione reciproca, il cui comportamento collettivo non può essere descritto semplicemente come la somma del comportamento dei singoli elementi. Frequentemente, alla complessità si accompagna un certo livello di auto-organizzazione, che emerge dal comportamento collettivo delle parti. Questa auto-organizzazione, che mantiene un sistema complesso lontano dal suo “destino” di dissoluzione termodinamica, contiene una certa quantità di informazione, che è codificata all’interno delle relazioni materiali tra le componenti del sistema.

Il matematico Norbert Wiener, uno dei pensatori più influenti del ventesimo secolo, fondò la cibernetica, una teoria interdisciplinare orientata allo studio dei meccanismi di autoregolazione dei sistemi viventi e delle macchine artificiali. Nel suo pamphlet del 1964 God and Golem, inc. dedicato al rapporto tra la tecnologia e la religione, Wiener traccia un parallelo tra la progettazione delle nuove macchine cibernetiche, potenzialmente capaci di apprendere e di auto-replicarsi, e il processo di costruzione del Golem. Il Golem, come corrispettivo artificiale e ‘tecnologico’ di un prodotto della creazione divina, è una figura ambigua, che ha spesso rappresentato il rischio di utilizzare la conoscenza per oltrepassare i limiti consentiti dell’azione umana. Eppure questi limiti non sono sempre legittimi: secondo Wiener anche la scienza contemporanea è limitata da un simile tabù, un timore superstizioso che ci impedisce di mettere sullo stesso piano gli organismi viventi e le macchine artificiali. Se si riuscisse a superare questo limite, però, si aprirebbe la possibilità di costruire sistemi artificiali dotati di capacità senza precedenti:
Persino nel campo della scienza è rischioso andar contro le gerarchie stabilite. In nessun caso è accettabile menzionare gli esseri viventi e le macchine nella stessa frase. Gli esseri viventi sono esseri viventi in ciascuna delle proprie parti; mentre le macchine sono fatte di metalli e altre sostanze disorganizzate, senza alcuna struttura fine rilevante per la loro funzione intenzionale o quasi-intenzionale. […] Se aderiamo a tutti questi tabù, potremmo acquisire una gran reputazione come pensatori conservatori e affidabili, ma contribuiremo ben poco all’ulteriore avanzamento della conoscenza[3]
La domanda a cui Wiener cerca di rispondere a partire dall’immagine del Golem è tutt’altro che banale. Esiste un “anello mancante” che possa mettere in relazione le macchine così come le abbiamo sempre concepite, ovvero come strutture inorganiche assemblate a partire da un’azione esterna, e gli organismi viventi capaci di organizzarsi spontaneamente? Al tempo in cui Wiener scriveva si trattava di un problema di grandissima attualità e rilevanza scientifica. Seguendo approcci diversi, intersecando fisica, matematica, chimica e biologia, moltissimi scienziati a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo hanno provato a formulare teorie che potessero rendere conto dell’organizzazione della materia, vivente e non vivente, abbracciandola nella sua complessità, cioè senza ridurla a un semplice “effetto collaterale” delle leggi, meccaniche o termodinamiche, già note per i sistemi semplici tradizionalmente considerati dalla fisica.
[1] Hans Driesch, The history & theory of vitalism, Macmillan, London, 1914. Treccani: entelechia. Termine usato da Aristotele in contrapposto a «potenza» (δύναμις), per designare la realtà che ha raggiunto il pieno grado del suo sviluppo.
[2] Riferimento: https://it.cathopedia.org/wiki/Verit%C3%A0_(Bibbia)
[3] Norbert Wiener, God and Golem, inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics Impinges on Religion, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, p. 5.
Per vedere tutti gli articoli di Duri e Muri – Extracts II, clicca qui
@ILLUS. by GENE-RICK, 2021, REMIX by PATRICIA MCBEAL
MENTI PARALLELE. Scoprire l’intelligenza dei materiali