HÖLDERLIN E IL SACRO

Quando ci si riferisce a Friedrich Hölderlin il collegamento immediato è con la risaputa follia che lo ha spinto a rinchiudersi per gli ultimi trentasei anni della sua vita (dal 1807 al 1843) in una stanza di un appartamento, nell’ala a forma di torriore (la cosiddetta Hölderlinturm). Sarebbe però riduttivo limitare l’interesse che ha suscitato tanto al suo tempo quanto a partire dal Novecento, riconducendolo alla sua bizzarra scelta.
Hölderlin fu poeta. E seppe esserlo probabilmente più di chiunque altro. Visse la sua vocazione con una profondità, con una immersione tale da totalizzarne completamente l’esistenza. Pagine e pagine sono state scritte sulla natura e sull’origine della sua patologia, della sua follia: le sue parole erano puro delirio? Aveva attinto ad uno strato di senso irriducibile ad un comune tedesco dell’epoca (e aggiungeremmo noi, ad un comune essere umano non affetto da malattie psichiche)? Quanta verità promava dai suoi componimenti? Karl Jaspers nel suo breve profilo patografico pubblicato nel 1922 (in un volume dedicato a Strindberg, confrontato con le figure di Van Gogh e Swedenborg) ci ha ragguagliato sulla natura dei rapporti tra genialità e follia: non scrisse ciò che scrisse perché folle. Altresì, non avrebbe scritto ciò che scrisse se non fosse stato folle. Genio sen’altro e folle senza dubbio, la follia ha splancato le porte di una sensibilità fuori dal comune, di una visione del mondo costruita con anni di studi e animata da una vivacità intelettuale di prim’ordine: senza follia non ci sarebbe stato Hölderlin; senza Hölderlin la follia mera tempesta di sabbia.
Allora il nucleo di un pensiero autentico va ricercato tra le spire di un tubine sacrificale, nei meandri di una scelta consapevole e solamente amplificata dai deliri sconnessi: come ci ricorda Maurice Blanchot (nella prefazione francese al testo precedentemente menzionato di Jaspers), coloro che visitavano il poeta nel ritiro della sua torre erano inondati dalla luce del suo pensiero, dalle parole di mediazione che promanavano dai suoi discorsi. E affinché si creasse la mediazione, affinché si edificasse la parola mediatrice, il mediatore avrebbe dovuto esporsi al pericolo più grande, al rischio della totale rottuta: abitare la follia come luogo liminale, di confine, a ben pensarci il non-luogo per eccellenza, per porsi come il tramite di una verità inesprimibile a parole eppure esprimibile esclusivamente tramite parole. Così Blachot:
[n]on è del suo destino che egli decide, ma è del destino poetico, è il senso della verità che egli si dà come compito da portare a termine, che egli compie silenziosamente, saggiamente, con tutte le forse della padronanza e della decisione, e questo movimento non è suo proprio, è il compimento stesso del vero che, a un certo punto e a dispetto di lui, esige dalla sua ragione personale che essa divenga la pura trasparenza impersonale, da dove non c’è più ritorno (Maurice Blanchot, Postfazione all’edizione italiana del testo di Jaspers, Genio e follia, p. 204).
È l’inagurazione di un pensiero poetante che tanta fortuna vedrà nel Novecento, ovvero l’avvicinamento al fuoco che brucia, al buco nero che risucchia la luce. L’impersonale evocato da Blanchot è la presenza di un abbandono, dell’abbandono orginario e originante la borghesia, la modernità, la follia: gli dei se ne sono andati, non abitano più la Terra. Orfani degli dei, esposti dagli dei, novelli Edipo ci aggiriamo, fuggitivi del destino; novelli Edipo ne siamo puniti, ciechi prima che accecati. Solo il poeta allora ha la forza per mediare il ritorno al costo del suo personale non ritorno: chi sono io per dirmi al cospetto di ciò-che-è? Il poeta è l’unico ad aver forza sufficiente per sopportare la dissoluzione, per dire la soluzione di un io e lasciar parlare, lasciar prendere forma di parola, il silenzio rigonfio di pericolo e di salvezza che è il Sacro (das Heilige).
Vicino
e difficile da afferrare il dio.
Ma dov’è il pericolo, cresce
anche ciò che salva.
Nella tenebra hanno dimora
le aquile e senza tema scavalcano
l’abisso i figli delle Alpi
su leggerissimi ponti.
Perciò, poiché intorno si ammassano
i culmini dei tempi, e chi più si ama
vive vicino, esausto su
monti separatissimi,
allora da’, acqua innocente,
dacci ali per partire e ritornare
più fedeli al senso.
Hölderlin, Patmos (prima stesura), strofa I, trad. it. di Susanna Mati
La citazione di Blanchot compare come Postfazione in Karl Jaspers, Genio e follia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, con la traduzione di Brigitte Baumbusch e Mario Gandolfi.
La poesia di Hölderlin è tratta dall’edizione curata da Sussanna Mati, Friedrich Hölderlin, Poesie scelte, Feltrinelli, Milano 2010.
@ILLUS. by PATRICIA MCBEAL, 2021



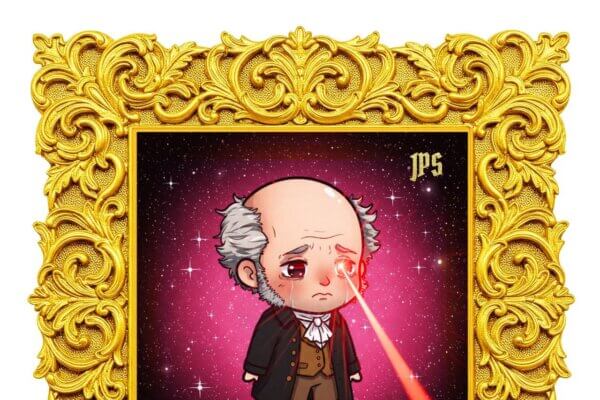

Bello l’articolo e soprattutto, i temi che vengono evocati. Holderlin, il poeta della lontananza e del pensiero poetante. Holderlin, il Leopardi tedesco. Entrambi hanno fatto del corpo proprio e della sua carica di desiderio, un veicolo di conoscenza. Entrambi hanno poetato a partire dallo spazio di una doppia negazione : il non più degli dei del passato e il non ancora degli dei venturi. È dal silenzio che nasce la parola poetica e nel silenzio si spegne, come un canto che lontanando muore. E dunque, back to Holderlin and Leopardi!