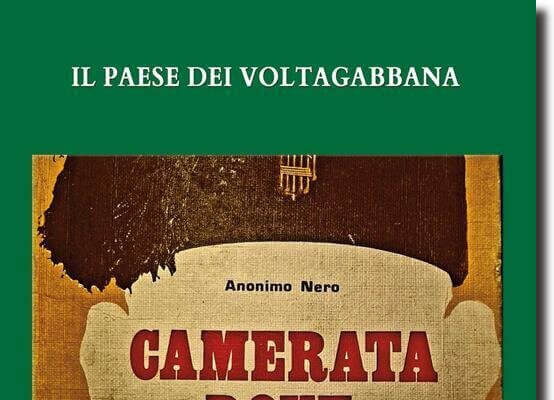L’OPPRIMENTE LEVITÀ DELLE PAROLE

Recensione a Maurizio Garuti, Conversazioni in lingua neolatrina, Edizioni Pendragon, Bologna 2018.
un inalberatissimo Nanni Moretti sbotta eruttivo (Palombella rossa, 1989). Già, la parole. Che sono pure importanti. Vanno soppesate: “la parola (la lingua) ferisce più che la spada” recita il noto motto popolare. La parola diventa strumento offensivo prima ancora di essere strumento comunicativo. Ma la parola è anche strumento difensivo: evolutivamente la parola ha segnalato il passaggio dalla mano alla bocca (Michael Corballis), dal gesto (gli schiaffoni di Moretti) alla parola (Leroi Gourhan), dall’offesa strumentalmente mediata (ti picchio con un sasso) a quella verbale che ha tracciato confini e palizzate. Per questo è offensiva. Ma che fine hanno fatto oggi le parole? Siamo sempre stati circondati dalle parole. In quanto esseri umani, il processo fonetico si è intrecciato sempre più con la nostra capacità, privilegio evolutivo, di pensare: la parola come immenso strumento, medium, traduttivo: tradurre il pensiero in parola, tramite la parola stessa. Meta-medium. Ma oggi le parole cosa sono diventate?
Ci invita a riflettere su questo interrogativo Maurizio Garuti, narratore (meglio: story teller; fa più figo-pro) e autore teatrale. Un tempo, infatti, le parole erano importanti:
queste acque purissime zampìllino perennemente [accentazione fondamentale: la parola, non dimentichiamocelo, è un suono, anche se scritta] per la salute del popolo (p. 9),
così campeggiava l’epigrafe sulla fontana pubblica del paese di Garuti (così dice lui; ma lo dice ed è questo ciò che conta) ad inizio Novecento. Il popolo fu colpito da una parola
[c]he mutò subito l’accento, perdendo il congiuntivo. E in quell’anno del Signore diversi neonati furono battezzati col nome Zampillìno (p. 10).
Un tempo, le parole facevano cose, meglio, facevano le cose. È stato Austin a certificare questa proprietà fattitiva delle parole nel suo Come fare cose con le parole (pubblicato postumo nel 1962, raccoglieva un ciclo di lezioni tenute all’Università di Harvard nel 1955). Era prepotentemente entrato in scena il performativo.
Per performativo si deve intendere ogni atto linguistico finalizzato all’istituzione di uno stato di cose. Oltre agli aspetti denotativo, ovvero oltre la semplice indicazione (“quello” o “questo”) e connotativo, cioè il contorno concettuale (il termine “libro” mi porta alla mente una serie di caratteristiche tali da permettermi di classificare e distinguere, financo definire, che cosa si debba intendere con la parola “libro”. Da notare come la connotazione del libro sia esogena: il libro come stato di fatto, il suo essere sul tavolo per esempio, è al di fuori della connotazione stessa), l’elemento performativo è il linguaggio che si metonimizza e che diventa fare: il sacerdote che dal pulpito dice ai fedeli “la Messa è finita, andate in pace” segna la fine effettiva della Messa. La Messa finisce nell’atto di proclamarne la fine.
Ecco che con le parole si sono fatte cose (certo, si parla di stati di cose e non cose in senso stretto, ma gli stati di cose sono formati da cose e dal loro relazionarsi statico, certificati a loro volta dalle parole). Tuttavia il performativo richiede almeno due circostanze esterne per poter fare le cose. Se il prof, al suonare della campanella, si mette ad affermare che la Messa è finita e che gli studenti possono andare in pace, di certo non sono le sue parole a far terminare la Messa che contemporaneamente si sta svolgendo nella chiesetta poco distante (perché semplicemente non si tratta di messa, ma di lezione!). Questo gaglioffo esempio sottolinea, però, l’importanza di una struttura contestuale adeguata al proferire. Il contesto diventa, pertanto, elemento determinante per l’istituzione dello stato di cose. Il diminutivo vezzeggiativo dipende dal contesto e dalla nostra percezione del contesto: amenità, tenerezza, familiarità. Carinissimo: «[è] la nostra percezione a determinare i gradi di carineria», ci ricorda Garuti. Per poi aggiungere
[i]nvece lo stronzo percepito può diventare stronzone, stronzetto o anche stronzino. Raro e poetico stronzinissimo (p. 61).
Provate a dare dello stronzone ad un papà che culla suo figlio nato da poco…
Al contesto si deve aggiungere l’apparato cognitivo dei soggetti agenti: modulare il registro linguistico diventa fattore primario e dell’efficacia della comunicazione e della possibilità di istituire stati di cose. Se non ci si comprende, non si va da nessuna parte:
Nonno, nonno! Cosa preferisci che faccio da grande: il blogger, il deejay, il freelance, il broker, il rapper, il performer o lo skipper?” [Il nonno:] “Se proprio devo scegliere, al turnidäur” (p. 21).
Probabilmente nessuno dei due si è capito. Hanno risposto Roma per toma e hanno fatto un quarantotto.
Così con il performativo le parole hanno assunto un peso specifico nuovo (in area concettuale), ma vecchio come il mondo: la parola si è fatta teatro, performance. Non a caso, il testo di Garuti è stato pensato e scritto per la sua messa in scena teatrale (monologo per il noto attore Ivano Marescotti). A teatro, infatti, le funzioni della parola e del linguaggio si fondono nella performance: denotazione, attraverso la gestualità del teatrante; connotazione, grazie al testo e al suo contenuto concettuale, performatività, nell’atto di recitazione che somma e invera gli altri processi.
Ma cosa resta della parola ora, che si volatilizza nell’iperproduzione di infinite pirlate opprimenti (pirlate nel senso etimologico: rotazione su se stessi)? Forse non parliamo ancora il neolatrino, ma stiamo abbandonando, questo sì, il neolatino. E lo stiamo perdendo grammaticalmente (i piccoli mattoncini che compongono il discorso, quelle paroline che puntellano la conversazione) e sintatticamente (la tramatura del pensiero). Il problema è che siamo traduttori piuttosto scarsi. Non traduciamo più il pensiero in parole e questo non per mancanza di pensiero, ma di parole. Un tempo le parole si adeguavano al pensiero ora, sembrerebbe, è il pensiero ad adeguarsi alle parole: poche parole, pochi pensieri (ma non pensiero; quello non ce lo toglie nessuno, neanche l’inopia verbale!). Ora le parole si fanno lievi, leggere, si buttano in faccia con virulenza (letteralmente: diventano virali), senza darne troppo peso. Ma, paradossalmente, mai come oggi le parole pesano. Non ci pensiamo perché non pesano sulla bilancia: mere flata vocis. Eppure nel restringersi della loro intensità ponderale acquisiscono un’opprimente pesantezza. E recitano, nell’atto teatrale estremo e perfetto della recita della recita, la loro sublime opprimente levità.
Per consultare le recensioni di Simone Vaccaro clicca qui
Per consultare l’archivio recensioni libri clicca qui