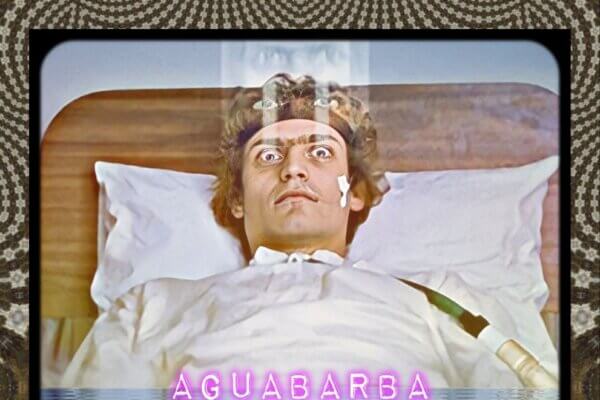UNA PAUSA DA APPLAUSI

Riflettevo sugli applausi e sul loro utilizzo non sempre giustificato. Succedeva, ch’io riflettessi, qualche settimana fa, mentre assistevo come molti altri alle esequie dei due poliziotti uccisi nella questura di Trieste. Giornata primaverile, un cielo azzurro terso che confondeva gli occhi per i colori le stagioni e i mesi dell’anno, più simile ad un aprile che ad un ottobre già pienamente avviato. Il silenzio della piazza gremita, lì dove inizia il canalone che va poi ad abbracciare il mare triestino, davanti alla Chiesa di Sant’Antonio Nuovo bianca di colonne, raccontava in maniera tremenda e potente la profonda solidarietà umana che riempiva l’aria, intervallata dai canti sacri amplificati dagli altoparlanti. La solennità del momento era evidente a qualsiasi latitudine intellettuale e spirituale dell’essere umano.
Un polmone enorme fatto di uomini e donne che respirava rispettoso e silenzioso e che pareva limitarsi a dire ci sono e mi unisco al dolore, quieto fino al momento di cordoglio e di commozione più elevato, il climax emotivo: l’uscita dei feretri avvolti nei loro drappi tricolori. Ed è a questo punto che avviene la trasformazione di quell’organo fino ad allora muto che testimoniava compatto la sua partecipazione, scattando inesorabile l’applauso della folla che scuote gli animi scrosciando violento. Risvegliato dalla tempesta di palmi, io che fino ad allora non avevo intenzione di rifletterci sopra, mi sono domandato se fosse realmente necessario a quel punto il dover applaudire.
Se non fosse ridondante il ribadire in quel modo la nostra presenza in quella tragica circostanza. Un abuso di segni. Tuttavia, nei pochi istanti in cui provo a ragionarci sopra, gli applausi divorano la mestizia e la compostezza delle mani giunte dei pochi che si rifiutano di cedere a quello che la stragrande maggioranza pare imporre, e travolgono la piazza in un vero e proprio tripudio.
Attonito, non trovo subito risposta alla mia perplessità, che permane anche quando rimango uno tra i pochi Silenziosi che non si uniscono alla rumorosa dimostrazione d’affetto. Intimamente infine, mi ero risposto che no, non era necessario applaudire. Almeno per me.
Cosa si deve applaudire di fronte ad un feretro imbandierato? Cosa manifesta un applauso se non una scaramanzia di che fortuna che questa volta non è toccato a me? Si applaude alle povere vittime, certo, ma a quale scopo? I morti non hanno orecchie, penso, e forse lo sbatacchiare di mani serve ai vivi come lavaggio di coscienza. Accade poi, fatto bizzarro, che si applauda quasi esclusivamente al termine di funerali di morti in maniera violenta, quasi mai durante riti funebri “ordinari”. Forse perché l’applauso è politicamente corretto e se applaudo è assolutamente evidente quanto io sia una persona retta giusta sensibile e di profonda empatia. Si tributa un omaggio per il passaggio dei defunti su questa terra, defunti che però non conosciamo, se non nei racconti che ci dicono (quasi sempre) che sono sempre i migliori che se ne vanno. Cosa aggiunge, un applauso, ad un dolore profondo?
Si applaude, da sempre. Al termine di rappresentazioni o orazioni o performance sportive di ogni tipo, battito di mani metafora dell’abbraccio a distanza e della gioia di compartecipare con il proprio sostegno e con la propria approvazione a qualche cosa di sensazionale, fuori dal comune, qualcosa di bello e di vitale. L’applauso è festa, non esorcismo e nella morte non c’è nulla di spettacolare o per il quale esultare. Meno ancora se questa è avvenuta all’improvviso, causata da fatti violenti, come nel caso degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.
Applaudire al termine di un funerale non è dunque una negazione della stessa natura celebrativa che tale atto porta in nuce? Peggio ancora se tale manifestazione non nasce spontanea, ma pare sobillata dall’agitarsi prepotente della massa che incalza e che trascina al suo interno tutti coloro che hanno il timore di essere tra i pochi contro corrente. Nel capannello al quale appartenevo, ad esempio, eravamo solamente in 3 a non applaudire e si percepivano maliziosi sguardi di disapprovazione da parte di alcuni di coloro che battevano le mani più forte degli altri per farsi ben sentire.
E questo ragionamento inconcludente ma accalorato che si svolgeva nella mia testa, mi ha portato a considerare il fenomeno applauso nel suo insieme. Nella sua natura dicotomica di medaglia da conquistare, possibilmente meritandolo, e di premio da tributare con gioia come riconoscimento. Ricompensa per chi lo riceve ma anche (e forse soprattutto) responsabilità per chi lo elargisce.
Bisognerebbe educare gli applausi e quindi tutti noi plaudenti ad utilizzarli con cura non deturpando la loro la potenza simbolica e utilizzandoli nelle situazioni che più competono loro. Che sono forse le situazioni della vita e della gioia, appunto.
Perché abusare degli applausi è una pericolosa abitudine: che si tratti di riconoscimento disonesto ma necessario al termine di uno spettacolo, atto giustificato solo dalla buona creanza che pare impedire ormai ogni forma di dissenso e disapprovazione; oppure che si tratti invece di situazioni per le quali questi non sono nati, non potendo competere con l’infinitamente superiore potere curativo del silenzio.
Per non rischiare che questa meravigliosa dimostrazione di affetto e ammirazione antica come l’uomo perda il suo potere di innalzamento allo straordinario e non si inaridisca in rituale per tutte le stagioni. C’è un tempo perfetto per fare silenzio, per dirla con Fossati. Ricordiamoci anche dei momenti perfetti per sbattere le mani.
Non svalutiamo l’applauso donandolo con leggerezza ed eleggendo a capolavoro ogni mediocrità e non utilizziamolo a sproposito laddove non è nato per esserci. Non è molto, ma anche attraverso queste piccole rivoluzioni quotidiane si può lavorare per un miglioramento di questo complesso complesso mondo.

Jacopo Morra è su Instagram
@ILLUS. IN EVIDENZA by AGUABARBA, 2020
@ILLUS. A TERMINE ARTICOLO by FRANCENSTEIN, 2020