SE ISTRUIRE NON VUOL DIRE “FORMARE”

L’articolo che qui proponiamo di Remo Viazzi è nato da uno scambio di battute su facebook a seguito dell’articolo Così la scuola forma ma non istruisce, pubblicato su Il Giornale l’1 aprile 2020 a commento delle misure eccezionali che sono state prese a causa dell’emergenza coronavirus.
Garantire a tutti gli studenti, come ha fatto il ministro Azzolina, la promozione all’anno scolastico successivo a più di due mesi dalla fine delle lezioni potrebbe sembrare una follia e, sicuramente, sarà controproducente per i livelli di apprendimento degli studenti e per il conseguimento degli obiettivi scolastici. Questi, piaccia o no, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno ancora bisogno del pungolo della “cara vecchia scuola”, fatta di voti, interrogazioni, richiami, per capire che studiare è bello e che il grado di istruzione raggiunto è spesso la chiave per ottenere nel corso della vita gli obiettivi che ci si era prefissati… Sempre ammesso che si voglia per forza continuare a sostenere che solo ciò che è utile serve.
In realtà così folle non è, dal momento che da qualche decennio a questa parte il Ministero, che pure mantiene nel titolo la parola “Istruzione”, dell’istruzione non sa proprio cosa farsene. Questa è stata bellamente sacrificata sull’altare dell’Europa a guida anglosassone dai chierici in servizio permanente della moderna psicopedagogia a tutto vantaggio del termine formazione, che nasconde, nel suo stesso etimo, la deriva totalitaria tipica del più bieco statalismo, che – come è noto – pretende di “prendersi cura” dell’individuo (persona non si può più dire) “dalla culla alla tomba”.
I due termini, istruzione e formazione, non vanno confusi. L’istruzione può essere parte della formazione di una persona, ma non è la stessa cosa.
Prendo dal Campanini – Carboni: tra i vari significati di forma, non tra i primi a dire il vero, si trovano anche parole preoccupanti: conio, archetipo, paradigma, stampo: tutti termini che ci rimandano all’idea di una cosa fatta in serie, sempre uguale a se stessa, paradigmatica appunto. Il Castiglione – Mariotti va anche oltre e arriva ad aggiungere le inquietanti accezioni quintilianee (uno che di istruzione un pochino se ne intendeva!) “tipo ideale, modello”. Così non può stupire che andando alla ricerca del valore intimo del verbo formare ci si imbatta sin da subito su plasmare, modellare, adattare, regolare. Basterebbe questo per comprendere la tendenza luciferina che si annida nella parola “formazione”: non interessa più dare dei contenuti (ma in senso più ampio potrei anche semplicemente dire “dare”), interessa plasmare degli individui, modellarli, adattarli alla società, farne dei “tipi ideali” di cittadini, attraverso l’introiezione delle “competenze di cittadinanza”, così vaghe e confuse che non si capisce ancora bene chi le debba insegnare, et alia varia. La scuola, ormai, vuole testare, quantificare, regolare e regolamentare non il livello di apprendimento degli alunni, ma le loro “competenze cognitive” in termini di “autocontrollo”, “perseveranza”, “resilienza (taaac!)”, “apertura mentale”, “grinta”, “carattere”. Tutte qualità dell’uomo assai difficili da valutare, da pesare, da quantificare e il cui conseguimento non dipende dal numero delle ore passate in un’aula scolastica, motivo per cui – ovviamente – la perdita di mezzo anno scolastico non può certo essere un motivo serio per metterne in discussione la validità. Anzi! Un anno come questo contribuisce assai più alla formazione dell’individuo che non le tante ore passate a scuola o a casa a studiare.
Quanto poi sia realmente “formativo” per gli alunni rendersi conto che quest’anno scolastico sarà loro “regalato” è tutto da dimostrare. Quanto possa accrescere la loro autostima è un mistero. Non sarebbe per loro più formativo, proprio perché crudele, prendere atto sin da giovani che nella vita non saranno poche le volte in cui accadranno fatti che andranno ben al di là delle loro possibilità di gestirli e che, pur non avendone colpa, si ritroveranno a pagarne il prezzo?
Qual è, dunque, lo scopo della “formazione” scolastica? Cito testualmente dal bel saggio di Ernesto Galli della Loggia L’aula vuota, pag. 187:
Si realizza così […] un vecchio sogno del Novecento totalitario: che la scuola non sia più in alcun modo un’altra cosa rispetto alla società, ma solo la sua ambigua, dura anticipazione. Nella quale […] si prendono le misure per meglio conformare il carattere di ognuno a ciò che si richiede per vivere in quella società…
Ci si potrebbe fermare qui, è già abbastanza terribile, ma preferisco andare avanti. Riparto dalla ricerca etimologica: instruo è il verbo latino. Quanto è più bello in ogni sua sfumatura! Congiungere, costruire, elevare, innalzare, fornire… E poi, naturalmente, istruire e insegnare. Qui non si impone niente a nessuno, non si plasma, non si modella, non si “forma”. Ognuno è libero di diventare quello che vuole, quello che si sente, non è un “tipo ideale” l’oggetto e il fine dell’instruere. La scuola, però, offre qualche cosa, dona, regala, aggiunge, costruisce insieme. C’è un’interazione tra docente e discente che fa sì che il docente riversi sul discente tutto il suo sapere, lasciando allo stesso la libertà di farne ciò che vuole.
Non spetta alla scuola la “formazione” di una persona: a essa concorrono moltissimi fatti, moltissime figure. Prima fra tutte – così almeno dovrebbe essere – la famiglia, alla quale non si può in nessun modo sottrarre il compito, il dovere, di educare e formare i propri figli; poi ci sono i parenti, gli amici, gli scout, lo sport, la parrocchia, i viaggi, i lutti e, andando avanti, perché la formazione è continua, il lavoro, i colleghi, la nuova famiglia, i figli e poi ancora nuovi lutti, disavventure, successi!
Una scuola basata sull’apprendimento dei “saperi”, a volte anche sulle nozioni, che aveva quale sua finalità precipua l’istruzione, consegnava agli alunni in uscita la “cassetta degli attrezzi” con cui affrontare la vita, oggi l’obiettivo è semmai quello di sfornare individui “formati” e conformati secondo un disegno che sta a monte e che è lesivo della libertà degli alunni e delle famiglie, quando ci sono.
Il successo di un brano come Another brick in the wall dei Pink Floyd, che ha appena compiuto 40 anni, e del relativo icastico video in cui gli alunni, spinti dall’insegnate, cadono in un enorme tritacarne che li riduce in poltiglia informe, in definitiva, deve la sua attualità non tanto al fatto di essere stato un’istantanea dei tempi che furono, quanto piuttosto una lucida e profetica anticipazione dell’oggi. Guarda tu la palingenesi dei fini!
Remo Viazzi, professore e saggista
Il libro di Ernesto Galli della Loggia cui l’autore fa riferimento è L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola, Marsilio, Padova 2019.
Per leggere tutti gli articoli della serie eccezionale Crisi coronavirus clicca qui.
Remo Viazzi è su facebook
@ILLUS. by, FRANCENSTEIN 2020
CRISI CORONAVIRUS
Vai all’indice LINK>>>
@GRAPHICS by MAGUDA FLAZZIDE, 2020




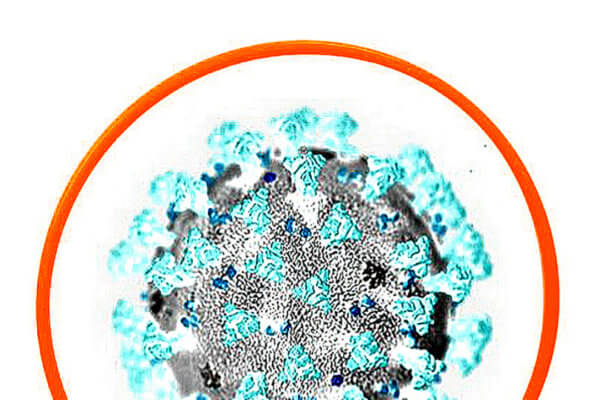



IN FUNDO
La scuola di massa è un mercimonio di saperi:
gli insegnanti li consegnano agli studenti per cavarci un interesse,
gli studenti li riconsegnano agli insegnanti per ricavarci un profitto;
così gli insegnanti si interessano degli studenti
e gli studenti si profittano degli insegnanti!
DULCIS IN FUNDO