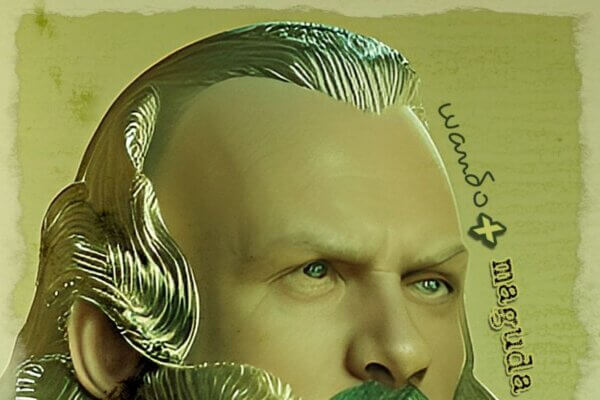MEONTOLOGIA DELLA LIBERTÀ (seconda lezione) II,4

…continua da Meontologia della libertà II,3 (qui)
Dopo aver letto ciò che Pareyson dice dell’EVENTO verrebbe da pensare che egli non considera come EVENTO la nascita, anzi, meglio: il concepimento di un essere umano. Basterebbe comunque anche solo riflettere un attimo sull’etimologia della parola E-VENTO per concludere che un E-VENTO è connesso eccome con ciò che lo precede: ex- + vĕnĭo = vengo da. Infatti, un figlio viene dai propri genitori: i genitori ne sono la causa ed egli ne è l’effetto, e-vento così come lui stesso, qualora un giorno decidesse di procreare a sua volta, da effetto si trasformerebbe in causa e così via. La catena generativa si fonda sulla trasmutazione dell’effetto in causa: per effettuare da sé un altro e-vento l’effetto causato deve trasmutarsi in causa efficiente come complemento di agente.
O buon Luigi! Il concepimento umano è l’evento degli eventi, ciò che massimamente si deve definire E-VENTO! Se poi, sottolineando il concetto di discontinuità e di sopresa nell’imprevedibilità dell’evento concezionale tu intendi dire che ogni essere neonato è diverso da tutti gli altri, unico e irripetibile, be’, questo è vero, ma non cambia la necessità eziologica dell’evento: per fare un figlio ci vuole un padre, per fare un padre ci vuole un figlio… così avrebbe cantato Sergio Endrigo se invece di cantare Ci vuole un fiore avesse cantato Ci vuole un padre… La “reversibilità” di paternità e figlialità è un fenomeno interessante della procreazione: i ruoli s’invertono per dare origine alla catena. Per fare un figlio ci vuole un padre, ma, per fare un padre ci vuole un figlio!
E dunque, caro Luigi, non è vero che un evento «non ha nessun addentellato con quanto lo precede», come sostieni, giacché ogni génito ha degli addentellati evidenti e innegabili con i suoi genitori. Però tu dici che un evento «è preceduto solo da un intervallo brevissimo, da un intervallo come per esempio la musica è preceduta dal silenzio…»: sarà, e se è così, il desistente ha la missione di dilatare, prolungare questo intervallo sino al punto in cui il silenzio si estenderà all’infinito e la musica tacerà per sempre. L’intervallo che fa riprendere fiato alla generazione è un «abisso», dici bene Luigi, «un abisso di tenebre», «il nulla», ma non «il nulla della libertà»: se Libertà ci fosse, il Nulla resterebbe tale e le tenebre non sarebbero squarciate dal lampo di luce di una vita neonata. Emanuele Severino ti bacchetterebbe, a sentirti parlare di questo Nulla: la tua obbedienza al dogma della creatio ex nihilo ti fa vaneggiare, o buon Luigi. La libertà della creazione è nulla, se un Principio primo non principiato trae dal Nulla un principio secondo principiato appunto da Lui: io non parlerei del nulla della libertà bensì di libertà nulla. Noi tutti siamo secondini del Primo principio, in questo carcere di condannati a morte: Lui, il Primo, Dio, crea il carcere e noi, eterni secondi, siamo le guardie carcerarie che si propongono di fare in modo che il carcere non resti senza detenuti? Triste storia, se è così!
«La libertà comincia dal nulla: il nulla della libertà. È un puro inizio nel vuoto di tutto. L’atto della libertà (…) è un atto di scelta a cui nulla preesiste». Mi pare evidente che qui Pareyson ha in mente il modello della Creazione divina così come essa è fissata nel dogma della creatio ex nihilo. Il modello divino viene impropriamente applicato all’uomo: non si tiene conto che se, nel caso eventuale di un Dio, può anche darsi un puro inizio nel vuoto di tutto, nel caso di un uomo, questo non può darsi, dacché è sicuramente discutibile definire Nulla l’assenza di un figlio non ancora concepito: io lo chiamerei Nessuno, Nemo, alla latina, e questo per il semplice fatto che quando una coppia di genitori concepisce un figlio non avvìa un processo per la prima volta bensì usufruisce di un processo già avviato dal Creatore stesso del Creato, tanto per stare al gioco teologico della creatio ex nihilo. Non so se è chiaro questo passaggio: un conto è considerare un Creatore divino che per la prima volta avvìa il meccanismo processuale della generazione, un altro è prendere in esame una creatura, anzi una coppia di creature genitoriali, che per la seconda, terza, quarta (eccetera) volta riavvìa tale meccanismo. Se un Dio può darsi nei termini cattocristiani, dobbiamo dire che Egli ha creato la modalità stessa della procreazione, la modalità che le creature seguono quando decidono di procreare; come dicevamo nel caso dell’identità di autore ed artefice, solo Uno (ma resta 1) che abbia il potere di inventare un procedimento può arrogarsi il brevetto, per così dire, cioè può compiere un atto di libertà «a cui nulla preesiste»; l’atto sessuale procreativo di un essere umano non è preceduto propriamente da Nulla: è preceduto dalla possibilità di procreare, e questa possibilità deve averla creata a priori Uno che ha prima creato l’essere umano procreante.
Stupisce, che Pareyson abbia fatto questo copia-incolla: dal Creatore alla creatura; stupisce che abbia copiato dal Creatore la modalità creazionale e l’abbia incollata sulla creatura tale e quale. Non è questo, il modo che la creatura può avere di essere a immagine e somiglianza del suo Creatore; beninteso che comunque bisogna poi crederci, a questa narrazione teologica. «Un evento, dunque, non è preceduto che dal nulla, e in questo risiede la sua libertà, anzi la libertà». Pareyson continua dicendo che un atto di libertà «non rientra in un sistema, non si aggancia a niente, non si concilia non niente, non ‘fa’ sistema…». Non fa sistema? In Genesi 9,7 il comandamento è chiaro e impone la catena di montaggio procreativa, la catena della “monta”:
E voi, siate fecondi e moltiplicatevi,
siate numerosi sulla terra e dominatela.
Umberto Galimberti, nei suoi libri, diverse volte si è scagliato contro questo imperativo divino; certo, non per gli stessi motivi del pensiero desistenziale, ma comunque per rilevare il “sistemismo” tecnologico di questo comando, o comandamento addirittura. Come fai, Luigione mio, a dire che la libertà «è un’auto-creazione, un’auto-posizione»? Quale essere umano ha mai creato se stesso quando è venuto al mondo? Nessuno: tutti siamo stati procreati da altri! Quale essere umano ha mai posto se stesso (in essere)? Nessuno: tutti siamo stati posti (in essere) da altri! Altri, cioè due genitori, ci hanno procreato e posti in essere, posti in vita. «La libertà è la scelta della libertà»? Scelta tardiva. «Non esiste l’essere libero ‘in potenza’»? Cosa dici, Luigione? Cosa stai dicendo? Sembri Severino, con questa polemica sulla legittimità del concetto aristotelico della ‘potenza’! Ma insomma, non meniamo il can per l’aia: almeno su una cosa possiamo essere sicuri, o no? Sul fatto, cioè, che quando uno non è ancora nato ancora non c’è? Almeno questo possiamo dirlo? Io, MAGISTER DAMNATUS, io, il PROFETA DELLA DESISTENZA, prima di essere concepito non c’ero. Punto. I miei genitori erano “miei genitori” solo in potenza, quando ancora non mi avevano concepito. Punto. Sono questi i punti fermi. C’è qualcuno che può confutare queste evidenti affermazioni? No. E allora di cosa stiamo parlando? Come si fa a dire che «non esiste l’essere libero ‘in potenza’: liberi lo si è solo in atto»? Lo si è solo dopo che l’atto sessuale fecondo ha attuato la potenza di procreare; sarebbe questa, la libertà del neonato?
Non si può chiudere gli occhi davanti al Nessuno che precede indubitabilmente l’assenza di Qualcuno. Se Qualcuno ancora non c’è, egli è Nessuno. «L’inizio assoluto è il nulla della libertà…»? In principio era il Nulla? Sì, magari per Dio Creatore; per quanto, anche Lui, non dovrebbe dormire fra due guanciali, sapendo che per creare Tutto ha dovuto deflorare il Nulla. Il Nulla che precede Tutto, il Nessuno che anticipa Qualcuno, questo Nulla & Nessuno possono essere ritenuti ininfluenti solo se si ipotizza una necessità di qualche tipo che costringa il Nulla a diventare Tutto per mezzo della Creazione e Nessuno a diventare Qualcuno per mezzo della Procreazione. O c’è uno stretto e indissolubile legame fra Nulla e Tutto, fra Nessuno e Qualcuno, oppure il Nulla può restare Nulla e Nessuno può rimanere Nessuno. «La libertà è in questo senso un mistero, che ha un aspetto esaltante e un aspetto opprimente, perché ha in se stessa la sua fondamentale ambiguità»? L’aspetto opprimente è per Pareyson la parte iniziata dell’Inizio, quella principiata del Principio; ma per noi desistenti ancor più opprimente è l’Inizio, il Principio: l’ermeneutica di un mito che impone di credere alla Creazione come Inizio dell’essere-creato e come Principio del medesimo. Questa spirale di violenza esistenziale non l’abbiamo messa in moto noi con un presunto Peccato originale fuori dal mondo: l’esperimento della creazione dell’uomo da parte di Dio, al di là del suo fallimento, è stato fatto da Lui, non certo da noi; per non dire che un Essere onnisciente poteva anche prevederlo, che le cose sarebbero andate male, no?
Luigi Pareyson passa poi ad esaminare l’altro attributo dell’EVENTO: l’irrevocabilità; imprevedibilità ed irrevocabilità sono infatti, lo si ricorderà, i due requisiti dell’EVENTO; evento che per la desistenza è sempre e soltanto eminentemente il concepimento (di un) umano. Quando tratta di irrevocabilità Pareyson fa il paio con Severino: «Un evento, un momento prima non c’era, e ora che non c’è non può più non essere». L’eternità dell’Essere, prima che esso sia e dopo che esso è stato, è l’assioma più inaccettabile del TOTALITARISMO ONTOLOGICO di Severino e Pareyson: la DITTATURA DELL’ESSERE. Un vero e proprio capestro, un contratto scandaloso “contratto” fra il Principio e il principiato nel nome di un “contatto” molto discutibile; un contratto che si contrae come una malattia, letteralmente. «La ‘possibilità’ prima del fatto non ha niente a che fare col fatto – dice Pareyson –, non lo anticipa, né lo prepara»; questo assunto si può spiegare così: prima che Qualcuno sia (procreato), egli è Nessuno, così come prima che Tutto fosse (creato), esso era Nulla. Nel senso che non c’è una corrispondenza biunivoca fra l’Essere impersonale (Nessuno) come potenza di procreare questa persona (Qualcuno) e l’essere personale come atto che ha procreato questo individuo. L’atto procreativo individua, per così dire, l’Essere genericamente non ancora individualizzato: la Potenza come energia pura. Ebbi a scrivere nel mio saggio intitolato Il dio “Già”:
In Metafisica 1019a.1 si dice che «tutte quelle cose che possono esistere indipendentemente da altre» sono anteriori, «mentre queste altre non possono esistere senza di quelle»; ora, se si congettura un dudum da sempre iam si deve credere alla preesistenza di un Atto assolutamente puro per il quale non può darsi nondum: Dio. La necessità aristotelica di pensare Dio come Atto e non come potenza deriva dal fatto che Egli deve poter essere Causa prima di tutto; per dirlo in termini esperibili concretamente: solo se c’è un genitore in atto può generarsi un figlio, il quale ultimo è quindi solamente in potenza finché detto genitore non lo genera. La mentalità ontologica disprezza l’essere-in-potenza perché, come si può vedere dall’esempio del genitore e del figlio, un essere-in-potenza non può che essere effetto di un essere-in-atto, e quindi ciò che è in potenza dipende da ciò che è in atto come un effetto dalla propria causa. L’essere-in-potenza è un essere che non (c’)è ancora: nondum ens. L’essere-in-atto è un essere che (c’)è già: iam ens. Il primato dello iam è la priorità dell’essere: lo nondum ens è sottoposto e subordinato allo iam ens. Ma, se ci si pensa in modo spassionato e oggettivo, niente impedisce che il primato e il predominio possano essere attribuiti al nondum ens: disinnescare la potenza dell’essere, vale a dire la potenza di porre in essere, è l’intento della desistenza; la potenzialità dell’essere come Ergìa ha bisogno dei genitori, per attuare il suo fine: senza genitore nessun essere può diventare in atto ciò che in potenza può diventare.
Il primato dell’Atto rispetto alla Potenza, come ho già scritto altrove, è la conseguenza logica del primato dell’Essere, primato che il pensiero desistenziale rigetta in toto. Aristotele ha la sua bella parte di responsabilità, in questa ontodicea che ha portato il catechismo della Chiesa Cattolica a importare dalla Summa di San Tommaso d’Aquino il dogma di Dio come Atto Puro. Pareyson sembra totalmente succube di questa mentalità, ma il suo sforzo di salvare la libertà umana si schianta contro l’impossibilità, per una Potenza (procreativa), di non aver niente a che fare con l’Atto (creatore) che quella Potenza rende possibile. Insomma, detto in soldoni, se uno, come Pareyson, accetta il dogma indimostrabile della Creazione, deve anche accettarne il corollario: qualunque Potenza di cui la creatura può usufruire è conseguenza diretta dell’Atto di un Creatore che l’ha resa possibile; la possibilità di procreare (da parte delle creature) è una Potenza che è stata “attivata” dall’Atto creatore (di Dio). Non è qui in questione il fatto che una Persona non sia biunivocamente collegata all’Essere impersonale che lo sovrasta a priori (su questo si può convenire con Pareyson salvando l’effetto sorpresa di una libertà che tanto gli piace), quanto piuttosto la considerazione che una Persona può essere “impersonata” solamente a condizione che il processo di “personificazione” sia potenzialmente attivato dall’Atto stesso della Creazione, al di là del fatto che qualcuno ne usufruisca o meno.
Il Desistente è semplicemente uno che non vuole usufruire della Potenza di Procreare; non vuole godere (!) del diritto di attuare in fase procreativa ciò che in fase creativa il Creatore attuò. Anche perché c’è poco da godere, se si esercita un tale diritto. Altrove ho definito ‘effetto domino’ quello della catena riproduttiva umana in senso procreativo: un Dominus (Signore) domina l’Atto creatore e un Servus (Schiavo) serve alla Sua causa usando il diritto di procreazione. M’è venuto in mente leggendo il passo in cui Pareyson dice che «conseguenze incalcolabili» della libertà non si possono prevedere: «cominciata dal nulla, la serie iniziata dalla libertà continua con effetto a valanga»; effetto Domino.
Per Pareyson il TEMPO e la MEMORIA serverebbero a fissare (pro tempore?) gli eventi. «Un evento non si può concepire che in termini temporali, ciò che lo definisce è un rapporto tra il ‘prima’ in cui non c’era e un ‘inizio’ (e perciò è temporale)». Essere e tempo. Essere è tempo. Martin Heidegger. Caro Luigi, se prima non c’era (un neonato), che ne dici di far sì che nemmeno dopo egli ci sia? Il bello della temporalità è proprio questo: che c’è un prima in cui non ci siamo e c’è un dopo in cui ci siamo, nella merda (speriamo che Emanuele Severino non ci senta). Quanto alla memoria, la memoria degli umani è corta e non costituisce un problema; il problema sarebbe costituito invece dalla Memoria di un Dio, sempre che ci sia, perché un Dio non dovrebbe poter dimenticare niente e proprio per questo Egli potrebbe punire eternamente nell’Inferno coloro di cui non ha dimenticato le colpe, gli sgarbi fatti alla sua Misericordia, gli sgarri fatti alla Sua Giustizia. Se Tempo e Memoria, come dici tu, Luigione, hanno il compito di “salvare” Tutto nel database dell’irrevocabilità, ripeto che questo potrebbe costituire un problema solo nel caso in cui veramente potesse darsi un Dio, perché allora la maledizione di Essere ad oltranza al di là del Tempo e dello Spazio terreno andrebbe incontro alla minaccia della Maledizione divina (un altro buon motivo per desistere).
Continua a leggere su Dexistens, “Meontologia della libertà” II,5 LINK>>>
Progetto Dexistens nel Network di Arena Philosophika, per vedere la home di Dexistens clicca qui.
@ILLUS. by JOHNNY PARADISE SWAGGER, 2020
MEONTOLOGIA DELLA LIBERTÀ – SLIM EDITION
♋ Meontologia della Libertà di Magister Damnatus ♋
@GRAFIC. by MAGUDA FLAZZIDE, 2020