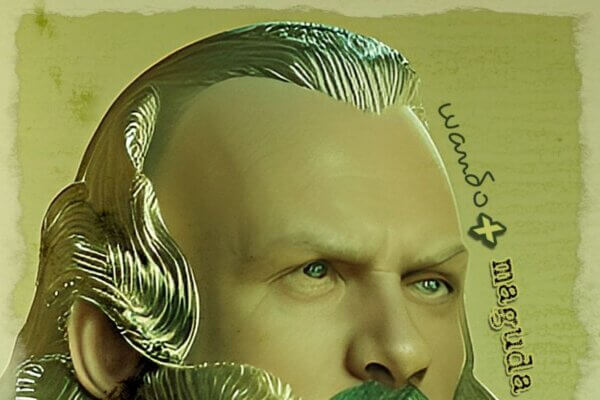CRITICA DELLA RAGION “IMPURA” (Parte I)

Leggendo il Teeteto di Platone ho elaborato la mia critica della ragion impura. Reduce dall’idealismo “inattuale” di Hegel e dall’idealismo attuale di Gentile, ho subito intravisto, nel relativismo protagoreo, combattuto da Platone per bocca di Socrate, il germe di quell’organismo idealistico elevato a sistema dalla filosofia dell’800.
Per costruire una critica della ragion impura basta seguire passo passo le argomentazioni di Platone / Socrate dialoganti con Teeteto. Innanzitutto, fissiamo in frasi icastiche tratte appunto dal Teeteto il pensiero di Protagora interpretato da Socrate:
ὡς τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ ἔστιν
«ciò che a ciascuno sembra, questo anche è». Uso la traduzione di Franco Ferrari edita per i tipi della Bur nel 2011. Si notino i verbi:
- δοκέω
- εἰμί
Il verbo δοκέω rispetto al verbo φαίνω significa ‘percezione’ non solo così come appare ma anche come è giudicata dal soggetto a cui pare: come appare e come pare. Non si deve infatti dimenticare che un parere è sempre tale secondo l’etimo del latino pārĕo il cui infinito pārēre significa «apparire» originando il sostantivo italiano «parere»; a dire che un parere è tale in quanto (ap)pare.
La concezione protagorea dell’homo mensura vuole che l’uomo sia μέτρον (= misura) di tutte le cose ma questo comporta la spiacevole conseguenza che
τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι
«ciò che pare a ciascuno questo anche è». A Socrate non va, di credere che ciò che pare anche è, perché per lui solo ciò che «è» è vero, mentre ciò che “pare” potrebbe essere falso: Platone ha bisogno di una Ragion pura super partes che dia verità a ciò che sembra affinché si possa dire che quod videtur non visum.
Ho coniato questo motto latino perché in latino videtur vuol dire «sembra» come voce del verbo vĭdĕor e visum vuol dire «cosa veduta» come voce del verbo vĭdĕo a ulteriore riprova che vedere e parere sono parenti, almeno da Platone in poi. Infatti, nel Timeo si dice che «chi ha visto qualcosa è diventato conoscente della cosa che ha visto» [163e] dacché «vista, percezione e conoscenza sono la stessa cosa» [164a]:
- ὁ ἰδών = il vedente
- ὁ ἐπιστήυων = il conoscente
L’episteme, la conoscenza veramente “scientifica” è platonicamente sempre eidetica, ma non alla maniera sensoriale di Protagora. Per Socrate
- τὸ ὁρᾶν ἐπίστασθαι = il vedere è conoscere
- τὸ μὴ ὁρᾶν μὴ ἐπίστασθαι = il non vedere è non conoscere
Ma, mentre Protagora dà alla semplice “veggenza” di un parere la verità del suo fenomeno, Socrate la dona solo alla “preveggenza” eidetica del suo essere epistemicamente vero.
Noi vediamo una cosa, poi chiudiamo gli occhi e continuiamo a vederla nel ricordo – dice Socrate –, ma, se l’averla vista fosse solo percezione sensibile, l’assenza della percezione dovrebbe far dimenticare la percezione stessa, cioè la “visione”: e così è, per Socrate; quindi, non si può credere che una cognizione vera sia solo il frutto di una percezione sensibile (= falsa). Leggendo il testo originale greco, è interessante notare che il verbo μύω usato da Platone per significare il “chiudere gli occhi” ci parla del μυστᾰγωγός (-οῦ, ὁ) come μύστης + ἄγω = iniziato ai misteri dacché il mistero del μύστης è voce del verbo μύω (!). Attenzione, sembra dirci Platone: “chiudere gli occhi” e vedere ancora è mistero μυστικός (= relativo ai misteri iniziatici) dacché solo l’iniziato vedendo μύω legge ἀνάμνησις (-εως, ἡ) come ἀναμιμνῄσκω = ἀνά + μιμνῄσκω = far ricordare. Secondo Platone, l’iniziato sa che ad occhi chiusi si continua a vedere perché ci si ricorda di ciò che si è visto altrove: in quel “mondo” celeste dove ci sono tutte le “matrici” delle conoscenze terrene.
A rigore, Protagora, chiudendo gli occhi, non dovrebbe vedere più nulla di ciò che ha visto, perché non è platonicamente iniziato; e infatti Socrate pensa che una sensazione pura e semplice non possa dare nessuna conoscenza stabile, cioè permanente. L’equivalenza percezione [αἴσθησις (-εως, ἡ)] = conoscenza [ἐπιστήμη (-ης, ἡ)] non sta in piedi, per Socrate, perché ἐπίσταμαι = ἐπί + ἵσταμαι cioè «sto sopra». Se «l’espressione “non vede” (οὐχ ὁρᾷ) equivale a “non conosce” (οὐχ ἐπίσταται)» [164b] l’espressione “vede” significa “conosce” e… finita la visione, gabbata la conoscenza!
Nel V canto del Paradiso Dante fece dire alla sua “Grazia”:
Apri la mente a quel ch’io ti paleso
e fermalvi entro; ché non fa scienza,
sanza lo ritenere, avere inteso.
Noi, sulla scorta di questo famoso passo, potremmo far dire a Socrate che “non fa scienza, sanza lo ritenere, aver sentito” laddove ritenere è conoscere rivedendo e sentire è percepire vedendo.
Se per “vedere” si intende solo un atto sensoriale, si va incontro al paradosso così posto da Socrate nella domanda retorica: «è possibile che colui che sa (εἰδότα) qualcosa, non sappia (μὴ εἰδέναι) ciò che sa?» [165b]. La risposta dovrebbe essere, ovviamente: no! Ma se le percezioni sono quei «fenomeni privati» (ἴδιαι αἰσθήσεις) che vorrebbe Protagora, la loro memoria [μνήμη (-ης, ἡ)] non è ricordo stabile (ἐπί + ἵσταμαι) di cose veramente imparate in una “matematizzazione” ben impostata [μάθημα (-ατος, τό /ᾰα/)] bensì oblio vano [λήθη (-ης, ἡ)] di un latitanza (λανθάνω e λήθω) incapace di fondare la verità [ἀλήθεια (-ας, ἡ /ᾰα/)]: verità è ἀ + λήθη = presenza parente e non apparente.
Il mistero a cui vanno iniziati gli amanti di “Sofia” è che anche ad occhi chiusi (= μύω) ciò che si è sentito nella αἴσθησις (= percezione) dell’essere è ricordato nella μάθησις (= sapere) dell’ente:
ὁ δε ὁρῶν = ὁ ἐπιστήμων
Il vedente è il conoscente. A parere di Socrate, Protagora è “non vedente” perché sostiene che
πάντων χρημάτων ἄνθρωπον μέτρον
di tutte le cose l’uomo è misura. Occhio, però, perché ci sono cose e cose… direbbe Socrate; in greco, infatti, χρῆμα (-ατος, τό) significa beni, ricchezze, averi mentre per dire “sostanze” nel suo doppio senso di averi e di essere si usa οὐσία (-ας, ἡ): le sostanze dell’ οὐσία sono voce del verbo εἰμί (= essere) mentre gli averi del χρῆμα sono voce del verbo χράω (= prestare). Tra essere e avere, com’è noto, Platone / Socrate sceglie l’essere. In greco τὸ χρή è il destino in quanto χρα(ύ)ω: è necessario, tant’è che χράω si usa anche nel senso di vaticinare, dare responsi, essere annunciato da un oracolo…
Già. Oracolare viene da ōrāre che vuol dire parlare e poi anche pregare (ma prima parlare): è il greco χρησμός (-οῦ, ὁ) perché χρή vuol dire “bisogna”. Eccola qua, la ragion pura di Socrate: l’oracolo di un εἴδω (= vedere) sensibile perfetto nel suo οἶδα (= vidi) ontologico. Per Protagora la conoscenza è “oracolo” di una “fania”, per Socrate è oracolo di una epifania.
Protagora è morto! proclama esultante Socrate con gli stessi accenti trionfali che saranno, secoli dopo, quelli stessi del Gott ist tot di Friedrich Nietzsche. Socrate vinse i figli della terra e Nietzsche i figli del cielo: questa la gigantomachia. Socraticamente, il vero sapiente è μαθὼν καὶ μεμνημένος (= sapiente e rammemorante). La memoria. L’ ἀνάμνησις platonica non è molto diversa da quella cristiana, la quale ultima, nella preghiera eucaristica della messa, è memoriale della morte e resurrezione del Cristo: l’eucarestia stessa è memoriale, come lo è quella profanissima “messa” socratica che è la celebrazione maieutica della conoscenza.
Mentre da una parte Protagora, per bocca di Socrate, si ostina a sostenere che «è impossibile opinare (δοξάσαι) cose che non sono (τὰ μὴ ὄντα) e cose diverse da quelle che si provano (πάσχῃ)»: «queste sono sempre vere (ταῦτα δὲ ἀεὶ ἀληθῆ)», dall’altra Platone afferma che «non è di poco conto, che la questione stia in un modo oppure nell’altro» [169e] e per lui resta fermo che
- σοφία = ἀληθές διάνοια (sapienza = pensiero corretto)
- ἀμαθία = ψευδές δόξα (ignoranza = opinione scorretta)
Non è il caso di notare che la δόξα (= opinione) viene dal verbo δοκέω (= sembrare) e, alla lontana, socraticamente, anche dal verbo δέχομαι (= ricevere) nel senso latino di dignus & decet.
Continua a leggere: Parte II >>>
Progetto Dexistens nel Network di Arena Philosophika, per vedere la home di Dexistens clicca qui.
@ILLUS. by TEKATLON, 2020
CRITICA DELLA RAGION “IMPURA”
Indice >>>
@GRAPHICS by TEKATLON, 2020