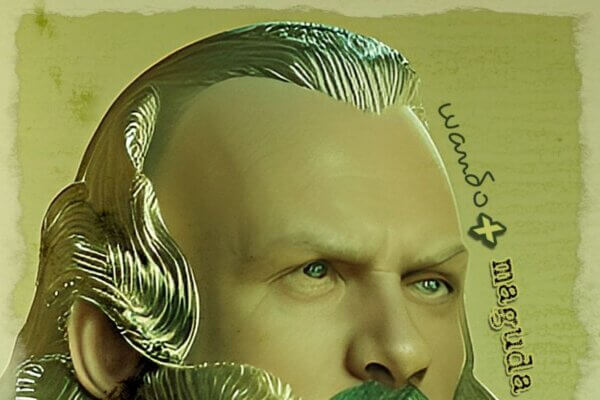CRITICA DELLA RAGION “IMPURA” (Parte II)

E veniamo adesso alla critica della ragion pura di Socrate, cioè alla critica della sua ragion impura. Se si va nei paraggi di Teeteto 170a-b si legge di Socrate che dice idealmente a un Protagora redivivo:
«…anche noi esprimiamo le opinioni di un uomo, anzi di tutti gli uomini, quando affermiamo che non c’è nessuno che non creda a proposito di alcune cose di essere lui più sapiente degli altri, e a proposito di altre che gli altri lo siano di lui; e quando sono di fronte a situazioni di grande pericolo, trovandosi in balia di battaglie, o di malattie o in mare, si attaccano a coloro che in ciascun ambito esercitano il comando come se fossero dèi, aspettandosi di venire salvati…».
Attenzione a quelle «situazioni di grande pericolo» e a quell’aspettativa di «venire salvati»: ἔν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις (= nei più grandi pericoli) compare l’attesa del Verbum σῴζω (= salvo). Il pericolo [κίνδυν (-υνος)] è la petizione di principio del salvatore [ὁ σωτήρ (-ῆρος, ὁ)]; il salvatore ha il diritto di diventare “arconte” nel senso di ἀρχός (-οῦ, ὁ) cioè di esercitare l’azione espressa dal verbo ἄρχω: l’ ἀρχή.
Se si pensa che all’inizio del suo vangelo Giovanni scrisse:
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
si capisce come l’ ἀρχή (= comando) platonica abbia potuto diventare l’ ἀρχή (= principio) cristiana! Ma, a parte questo discorso – che pur sarebbe interessante – in questa sede mi preme far notare che il platonismo socratico è sì alla ricerca dell’essere, ma a patto che questo essere serva a qualcosa. Ecco il punto: l’utilitarismo dell’ontologia platonica (e cristiana). Sembra, che qui Socrate stia criticando l’utilitarismo di Protagora, ma in realtà lo adotta in pieno, seppur in modo velato.
La “bontà” della μάθησις platonica è veramente buona se è buona a… se è cioè efficace, adatta a raggiungere uno scopo: ad + actŭs = adatto. Di per sé, adactum è participio passato di ădĭgo, ădĭgis, adegi, adactum, ădĭgĕre che vuol dire spingere verso, costringere, forzare… è il concetto heideggeriano di pro-vocazione”: l’uomo voca la natura a dargli ciò che gli giova (= pro) attraverso la forzatura della scienza e della tecnica, che costringono, letteralmente, la conoscenza a effĭcĕre ciò che si vuole; tale effĭcĭo è l’efficienza nel senso genuino, cioè platonico, di produzione. L’efficientismo dell’ontologia platonica è effĭcax in quanto ha effetto, fa effetto.
E, stando al gioco che le parole ci suggeriscono, si può veramente dire che “fa effetto” pensare che la verità della conoscenza stia nella sua efficacia. Ma c’è di più. Io percepisco, nella confutazione del protagorismo, la scomunica di un egualitarismo (doxastico) che è quanto di più lontano ci sia dall’autoritarismo (assolutistico) del totalitarismo ontologico. Non siamo tutti uguali – dice Socrate –: «uno è più sapiente (σοφώτερον) di un altro, e anche più ignorante (ἀμαθέστερον)» [171d], il che può anche starci; ma quando si sente dire che
«…se arriverà in qualche modo a concedere che in taluni casi un individuo differisce (διαφέρειν) da un altro, non è a proposito delle cose salutari e nocive che sarà disposta ad ammettere che non ogni donna o fanciullo, o addirittura animale, sarà in grado di curarsi (ἰᾶσθαι) da sé, conoscendo ciò che è per lui salutare (τὸ ὑγιεινόν), ma proprio in questi casi, se mai in altri, uno differisce (διαφέρειν) da un altro?» [171d-e]
In questo modo, secondo Socrate, la sua teoria «risulta molto più salda»: μάλιστα ἵστασθαι τὸν λόγον laddove non è chi non veda nell’ ἱστάω di ἵστημι quel sisto latino che porta all’ ἐπίστημι di ἐφίστημι (= innalzare); se si pensa poi che ἐπίστημα (-ατος, τό) è il cippo, il monumento funebre, l’ornamento, il trofeo si capirà come l’ontologia di Platone porta in trionfo solo l’episteme che sa curare e curarsi dell’uomo: ἰατρεύω (= curare). Matteo 9,12-13:
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
I “giusti” sono quelli ritengono giusta la verità del parere così come a loro pare: Protagora è il “giusto” che Socrate condanna e Cristo danna. Il “giusto” è il sano (di mente?): colui che non giudica manchevole la verità del parere, che non ritiene una mancanza il ritenere vero ciò che gli pare, che non considera un peccato credere ai suoi occhi.
Dopo Protagora, tanti furono i “giusti” che il cristianesimo condannò in terra e dannò in cielo: per esempio, Friedrich Hegel e Giovanni Gentile; l’uno per il suo “realismo inattuale” e l’altro per il suo idealismo attuale. Sono sempre i giudiziosi a condannare i giusti, e Socrate fu il campione, dei giudiziosi…
Continuando nello sforzo di confezionare un discorso ontologico che “stia in piedi”, il socratismo platonico continua a criticare il protagorismo dicendo che il discorso vale
«…anche per le questioni politiche: le cose belle e brutte, giuste e ingiuste, pie e non, quali ciascuna città, in base alle proprie convinzioni , stabilisca come norme per se stessa, queste in verità sono anche per ciascuna, e in questo ambito non c’è nessuno più sapiente, né un privato cittadino nei confronti di un altro privato cittadino, né una città nei confronti di un’altra città. Mentre nello stabilire ciò che giova a sé o ciò che non giova (ἐν τῷ συμφέροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ συμφέροντα τίθεσθαι), in quest’ambito, se mai, converrà che un consigliere differisca da un altro e un’opinione della città da un’altra quanto a verità, ma non oserebbe sostenere che ciò che una città stabilisce ritenendolo vantaggioso per sé, risulterà anche in assoluto con certezza vantaggioso». [172a-b]
Il discorso è filosofico e politico ma sempre valoriale, nel senso che vero è ciò che vale a… ciò che è buono a…
Nel greco di Platone c’è un verbo fondamentale per capire l’origine efficientista dell’ontologia socratica: συμφέρω = σύν + φέρω = con + porto = comporto. Il verbo συμφέρω vuol dire ‘mettere assieme” e curiosamente σύμφορος (-ον) significa utile, vantaggioso e riceve da συμφορέω il significato di raccogliere (per sé), ammassare, congiungersi; la συμφορά (= capitale) di χρήματα (= averi) è giustificata dalla φορά (= versamento) di οὐσία (= sostanze).
Se συμφέρει σωφρονεῖν (= giova essere saggio) il giovamento deriva dal senso in cui il greco συμ-φέρειν equivale al latino inter-esse: intersum, interes, interfui, interesse (verbo intransitivo anomalo) che vuol dire stare in mezzo, esserci una differenza, importare, interessare… l’essere socratico comporta un interesse pratico. A rigore, però, un discorso sull’essere non dovrebbe subire le inter-ferenze dell’inter-esse.
Il συμφέρω interferisce con l’essere perché gli “allega” l’obbligo di una qualche efficacia. L’attualismo ontologico di Protagora non considera inutile l’inattualità di una δόξα : l’inattualità doxastica è inutilità ontologica solo se essa com-porta (σύν + φέρω) la necessità di una verità efficace; ma, così, la verità non è più una “ferenza” dell’essere bensì una inter-ferenza dell’inter-esse.
Lo stesso Λόγος cristiano, come Verbum Patris è teologicamente assoluto in quanto relativo al bisogno di salvezza, cioè di salvarsi la vita: paradossalmente, è l’essere “relativamente” a qualcosa ciò che assolutizza l’essere stesso! Un assoluto irrelato è l’essere come dovrebbe essere: un essere che non sia professato nell’interesse di esseri che lo ricercano per ciò che esso com-porta; penso al Natale cristiano e ai doni che porta… L’interesse comporta che l’essere sia assolutizzato perché è buono a salvare: buono a non far morire, buono a far vivere. Il vero assoluto dovrebbe essere, ontologicamente, un essere che non comporta nulla, un essere che non ci importa per ciò che ci porta.
Importare è interessare solo se l’interesse è disinteressato: l’interesse interessato non porta all’essere ma solo all’interesse per l’essere. L’essere umano tende ad assolutizzare l’essere che idealmente crede essere in grado di farlo essere: l’assoluto utilitaristico è quello assolutamente relativo all’interesse interessato. Assoluto è l’essere se fa essere: se serve a far essere gli esseri che ha fatto essere, che ha posto in essere.
Impura è una ragion d’essere che comporta un interesse interessato. Pura è una ragion d’essere che porta un interesse disinteressato. La teorizzazione socratico-platonica di una ragione che si mantenga pura stando lontana dall’interesse fenomenico ha comportato, suo malgrado, la teorizzazione di una ragione impura in quanto macchiata dall’interesse ontologico: l’impurità della ragion platonica è la falsità della socratica ragion impura.
Continua a leggere: Parte III >>>
Progetto Dexistens nel Network di Arena Philosophika, per vedere la home di Dexistens clicca qui.
CRITICA DELLA RAGION “IMPURA”
Indice >>>
@GRAPHICS by TEKATLON, 2020